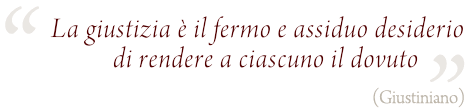rapporto di lavoro
Commento giurisprudenziale
IL PERIODO DELLE LEVA FA SEMPRE PUNTEGGIO
(Il servizio militare è valutabile per le graduatorie anche se svolto successivamente al titolo che abilita all’insegnamento)
E’ sempre valutabile ad ogni effetto, e quindi anche ai fini dell’attribuzione del punteggio in graduatoria, il servizio militare svolto dal personale scolastico successivamente al conseguimento del titolo di studio indispensabile per l’accesso al relativo profilo ovvero insegnamento, anche non in costanza di nomina. Così decide da ultimo il TAR Lazio, Sez. III bis con sentenza n. 624 del 2011, aderendo ad un pacifico e consolidato orientamento giurisprudenziale, anche del Consiglio di Stato (cfr TAR Lazio, Sez. III- bis, nn. 7259/2010, 325/2010, 27482/2010 ; TAR Lazio Sezione III –quater, 8.7.2008, n. 6421; TAR Sardegna 26.1.2006 n.74; TAR Sicilia, Catania, 14.6.2005 n.982; Consiglio Stato, sez. VI, 15.5.2003, n. 2650; Consiglio Stato, sez. II, 19.2.1997, n. 529; Consiglio di Stato, nn. 4030/2009 e 4031/2009).
Occorre sul punto precisare che, a seguito del recente cambio di orientamento della giurisprudenza delle sezioni unite dalla Cassazione, le controversie in materia di formazione e gestione dei vari tipi di graduatorie scolastiche, vertendo su atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato - a fronte dei quali sono configurabili diritti soggettivi degli aspiranti, in possesso dei prescritti requisiti, all’inserimento nella graduatoria ed all’instaurazione del rapporto di lavoro con la scuola - sono devolute ai giudici ordinari e non più ai TAR. Il giudice valuta la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione e del mero riscontro della sussistenza dei presupposti previsti dalla legge. Tali controversie rientrano pertanto nella giurisdizione del giudice ordinario, e in particolare, soggiacciono alle norme processuali del rito del lavoro (cfr. Cassazione, Sezioni Unite 8.2.2011 n. 3032; 10.11.2010 n.22805; e Cassazione, Sezioni Unite, n. 3399/2008, n. 1203/2003, n. 11404/2003, n. 1989/2004, 11563/2007, 14290/2007). Si auspica tuttavia che anche l’autorità giudiziaria ordinaria – in particolare, il giudice del lavoro - vorrà far proprio il consolidato principio su citato.
Ciò soprattutto perché tuttora l’amministrazione scolastica – in asserita applicazione delle disposizioni ministeriali succedutesi negli anni – nega l’assegnazione di un punteggio pieno al servizio militare di leva o sostitutivo assimilato ove prestato in periodi non coperti da una nomina, ma pur dopo il conseguimento del titolo per l’accesso al profilo o all’insegnamento. In tal modo, i soggetti interessati - che avrebbero potuto ricevere i medesimi incarichi senza poterli accettare trovandosi alle armi - risultano ingiustamente discriminati e penalizzati rispetto ai colleghi che abbiano avuto la buona sorte di prestare il servizio militare durante l’espletamento di un servizio d’insegnamento e non anche coloro. I primi, si vedono ancora oggi assegnare un punteggio pari a punti 0,60 per l’anno di leva, anzichè punti 6 come di diritto, e così ingiustamente sopravanzare dagli altri aspiranti con gli stessi titoli di studio e di servizio.
La vicenda
Il ricorrente impugnava la graduatoria nella parte in cui non gli era stato riconosciuto il punteggio per il servizio militare dichiarato in domanda e prestato successivamente al conseguimento del titolo abilitativo all’insegnamento, nonché il le norme ministeriali che valutano valuta il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati solo se prestati in costanza di nomina.
Il Tar del Lazio, considerato che il ricorso è manifestamente fondato, sulla base dell’orientamento giurisprudenziale affermatosi anche in sede cautelare e ai sensi dell’art. 485, comma 7, del d.lgs. n. 297/1994 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione e scuole di ogni ordine e grado), lo accoglie dichiarando l’annullamento della graduatoria e della norma ministeriale nelle parti impugnate.
Motivi della decisione
Il giudice ricorda che l’art. 485, comma 7 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione e scuole di ogni ordine e grado, in via generale, prevede testualmente che “Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”. La valutabilità del servizio militare è comunque condizionata al fatto che esso debba essere stato effettuato dopo il conseguimento del titolo di studio (diploma o la laurea) indispensabile all’accesso dell’insegnamento medesimo, ovvero – nel caso di personale non docente - , per l’accesso il profilo, in quanto la valutabilità è logicamente collegata al fatto che il servizio militare obbligatorio poteva essere di ostacolo all’instaurazione del rapporti di servizio.
La portata assolutamente generale del settimo comma dell’art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, che non è connotata da limitazioni di sorta, comporta che il riconoscimento del servizio debba necessariamente essere applicato anche alle graduatorie, onde evitare che chi ha compiuto il proprio dovere verso la nazione si trovi poi svantaggiato nelle procedure pubbliche selettive.
Da tanto consegue l’illegittimità delle norme ministeriali in tema di valutazione di titoli e servizi nella parte in cui prevedono che il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge siano valutabili solo se prestati in costanza di nomina. Diversamente, ove si accogliesse la tesi che il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge siano valutati solo se prestati in costanza di nomina in quanto, del tutto arbitrariamente si finirebbe per favorire solo coloro che abbiano avuto la buona sorte di effettuare il servizio militare durante l’espletamento di un servizio d’insegnamento e non anche coloro che avrebbero comunque potuto ricevere i medesimi incarichi d’insegnamento senza poterli accettare trovandosi alle armi.
Per l’effetto, il Tar del Lazio conclude con la pronuncia di annullamento degli atti impugnati (graduatoria e norme ministeriali, nelle parti oggetto di gravame) e di accertamento del diritto alla piena valutazione del servizio militare.
Anna Nardone
Pubblicato su “Il Sole 24 Ore Scuola” n. 12 del 10 – 23 giugno 2011
Commento giurisprudenziale
ILLEGITTIMO ABUSARE DEI CONTRATTI A TERMINE
(Alcune scuole condannate a trasformare rapporti precari in posti a tempo indeterminato)
E’ illegittima l’apposizione del termine sui contratti di supplenza ripetutamente stipulati tra l’amministrazione dell’istruzione e il personale scolastico precario, e pertanto il primo contratto stipulato fra le parti va convertito in contratto di lavoro a tempo indeterminato, con conseguente al pagamento di una somma commisurata alla ricostruzione della carriera lavorativa in termini di differenze retributive.
Anche il Tribunale di Livorno, dopo quello di Siena, ritiene di sanzionare l’abuso del ricorso ai contratti a termina nella scuola con la trasformazione dei rapporti precari in rapporti a tempo indeterminato, richiamando i principi enunciati dalla Corte Europea e le indicazioni interpretative dell'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione (cfr. Tribunale di Livorno, sez. Lavoro, 25.1.2011; cfr. anche Tribunale di Siena, sez. Lavoro, 15.10.2010).
La vicenda
I ricorrenti avevano prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato quali docenti precari, per diversi anni. Secondo la normativa vigente, dopo due assunzioni successive a termine il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto, contenendo tale norma una presunzione assoluta di finalità fraudolenta nella successione dei contratti a tempo determinato. La finalità del Ministero dell’istruzione era infatti quella di assumere ogni anno un gran numero di insegnanti necessari a far funzionare la scuola, senza contrattualizzarli in modo da assicurare loro le minime garanzie di legge. Detti lavoratori subiscono disparità di trattamento rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato su una serie di punti fra cui retribuzione, ferie, malattia, permessi, TFR.
I ricorrenti si rivolgevano perciò al giudice chiedendo l’accertamento di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il Ministero, con conseguente ricostruzione della carriera ai fini previdenziali, pensionistici, di anzianità e retributivi e condanna dell’amministrazione al pagamento delle differenze retributive dovute in base alla ricostruzione della carriera.
Il Ministero della Pubblica Istruzione sosteneva l’infondatezza del ricorso. Ribadiva l’impossibilità di assimilare il rapporto di lavoro privato al rapporto di lavoro pubblico, cui si accede per concorso, per cui unica tutela per i lavoratori davanti la violazione di norme imperative in ordine ai contratti a termine rimane quella risarcitoria, essendo impossibile la trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato.
Il giudice ha ritenuto invece più fondate le ragioni del personale scolastico ricorrente.
Motivi della decisione
Secondo la legislazione vigente il contratto a tempo indeterminato è il tipo contrattuale generale dell’ordinamento italiano a cui si può derogare con lo speciale contratto a tempo determinato solo a specifiche, precise condizioni. Ciò è stato anche riaffermato dalla giurisprudenza nazionale ed europea, la quale ha sostenuto che il beneficio della stabilità dell’occupazione costituisce un elemento portante della tutela dei lavoratori.
Ugualmente è pacifica nella giurisprudenza della Suprema Corte la regola secondo cui alla nullità della clausola appositiva del termine inserita nel contratto di lavoro per violazione di legge consegue l’invalidità parziale relativa alla sola clausola e l’instaurarsi di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (cfr. Cass. n. 6328/2010 cit., conf., Id. n. 12985/2008). La Cassazione ha argomentato nel senso che a tale conclusione è dato pervenire attraverso l’interpretazione di direttive comunitarie, della giurisprudenza della Corte di Giustizia, delle norme nazionali, della giurisprudenza della Corte Costituzionale sulla inderogabilità tipica delle norme poste a tutela dei lavoratori.
Nella specie, è pacifico – neppure contestato dall’amministrazione – che i contratti a tempo determinato con i supplenti venivano stipulati in violazione di norme imperative poste a tutela del lavoratore. L’unico punto realmente controverso fra le parti, quindi, è la sanzione da comminare per detta violazione. Si tenga conto che ci troviamo davanti ad una continua ripetizione di contratti a termine, tutti volti a coprire carenze di personale in assenza di qualsiasi concorso o assunzione regolare.
Detta sanzione nel nostro ordinamento allo stato attuale sarebbe solo un risarcimento monetario nei termini di cui al collegato lavoro recentemente entrato in vigore, cioè un risarcimento che non ricostruisce la carriera in termini retributivi e previdenziali.
Ma è compito del giudice dell’ordinamento interno, secondo la corte di Giustizia, verificare la soddisfazione dei requisiti di adeguatezza della sanzione, cioè del carattere non soltanto proporzionato, ma altresì sufficientemente effettivo e dissuasivo.
Di fronte a abusi di reiterazione di venti o più anni di contratti a termine, però, anni che sono la vita lavorativa di una persona e ne segnano la qualità in termini negativi, impedendogli progettualità, togliendogli retribuzione, pensione, stabilità, il semplice risarcimento di una somma di denaro non può essere considerato - secondo il Tribunale di Livorno - congrua sanzione. Tanto più se si considera che tale comportamento deriva dallo Stato, ovvero da chi più di altri è tenuto ad osservare le leggi e i principi dell’ordinamento, e che invece viola costantemente l’art. 97 Costituzione sulla necessità del concorso per le assunzioni, utilizza il contratto a termine senza alcuna effettiva necessità, visto che detto termine dura più anni, e non è confacente ad esigenze temporanee.
Sanzione adeguata quindi, secondo i principi dell’ordinamento italiano ed europeo, e secondo i principi costituzionali, è la conversione del rapporto di lavoro in lavoro a tempo indeterminato cui si aggiunge la somma di danaro.
Ciò disapplicando le norme nazionali inadeguate sotto i profilo dell’effettiva tutela ai lavoratori, ed applicando le direttive europee, la giurisprudenza della Corte di Giustizia, come già recente giurisprudenza di merito ha precisato ( si veda Trib. Siena, sentenza 15.10.10 nella causa r.g. n. 662/2010).
Anna Nardone
Pubblicato su “Il Sole 24 Ore Scuola” n. 5 del 4 -18 marzo 2011
Commento giurisprudenziale
NON E’ LECITA L’ESCLUSIONE DEL PROF NON COMUNITARIO
(di segno opposto altre decisioni della Cassazione che giustificano l’estromissione dei supplenti dalle liste)
E’ discriminatoria la condotta dell’amministrazione che esclude un docente extracomunitario dalla graduatoria degli aspiranti ad incarichi di docenza. sulla base del solo difetto del requisito della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’U.E. Così decide il Giudice del lavoro di Milano, ordinando alla medesima amministrazione di inserire il docente ad ogni effetto nella graduatoria di spettanza, senza alcuna riserva relativamente al requisito della cittadinanza (Ordinanza 11.1.2010).
La pronuncia assume una posizione per nulla pacifica in giurisprudenza, state le decisioni di segno opposto pure della Cassazione, che giustificano - anche sotto il profilo costituzionale - l’esclusione dello straniero non comunitario dall’accesso al lavoro pubblico, al di fuori di eccezioni espressamente previste dalla legge (Cass. 13.11.2006 n. 24170).
La vicenda
Il ricorrente, di nazionalità canadese, regolarmente residente in Italia, presentava domanda per l’inserimento nella graduatoria degli aspiranti ad incarichi di docenza. Ritenuto in possesso dei requisiti e titoli richiesti dalle norme vigenti, il medesimo veniva regolarmente inserito nella graduatoria con il punteggio di spettanza, e quindi incaricato dall’amministrazione in qualità di supplente. Sennonché, la nomina veniva poco dopo annullata perché il docente era ritenuto non in possesso del requisito della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’U.E. Il docente proponeva ricorso al giudice del lavoro domandando l’accertamento della natura discriminatoria del comportamento tenuto dall’amministrazione e l’ordine di cessazione del medesimo comportamento pregiudizievole. Il giudice adito ha accertato la natura discriminatoria e lesiva della condotta dell’amministrazione e condannato il Ministero ad inserire il docente nella graduatoria a tutti gli effetti di legge.
Motivi della decisione
Il Tribunale del Lavoro prende le mosse dal quadro normativo nazionale e comunitario di riferimento, chiaramente orientato a sostenere il principio di uguaglianza e parità di trattamento fra cittadini extracomunitari e cittadini italiani, tendendo a rimuovere tutti gli ostacoli destinati a frapporsi al perseguimento della finalità generale. A tal proposito fa riferimento all’articolo 3 della Costituzione che fissa il principio generale di uguaglianza riferibile anche ai non cittadini; e alle norme interne e internazionali ratificate che impegnano l’ordinamento a promuovere e garantire la parità di opportunità di trattamento in materia di occupazione e professione per le persone che si trovino regolarmente sul territorio.
Posto il quadro normativo di riferimento, il fine del perseguimento della tutela del lavoratore extracomunitario e della parità di trattamento deve ritenersi non ostacolato dalla natura “pubblica” del datore di lavoro. L’accesso degli stranieri alle dipendenze della PA oltre ad essere stato in più occasioni riconosciuto dalla giurisprudenza, trova anche supporto normativo in una serie di disposizioni (con riferimento a infermieri professionali, professori universitari e ricercatori; rifugiati).
Sotto questo profilo, una condotta come quella di specie – altrimenti discriminatoria - potrebbe essere giustificata solo da norme di rango superiore e/o derogatorie rispetto al quadro normativo su prospettato. Ed invero vi sono disposizioni che escludono l’accesso di stranieri a posti della PA che implichino l‘esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero attengano alla tutela dell’interesse nazionale.
Orbene, secondo il giudice, tenendo conto proprio dell’evoluzione normativa nazionale e internazionale in materia - che appare inevitabilmente e chiaramente indirizzata a parificare le posizioni di tutti gli individui sul mercato del lavoro - il principio generale deve essere quello dell’assenza di una qualsiasi ingiustificata differenziazione tra il cittadino italiano e straniero nell’accesso al lavoro, con il solo limite dello svolgimento di determinate attività che comportino l’esercizio di pubblici poteri o di funzioni di interesse nazionale. Tale ipotesi, che certamente legittimerebbe il trattamento differenziato, devono ritenersi - a parare del giudice – insussistenti nel caso di specie non solo perchè difetta una espressa previsione normativa, ma perchè tali requisiti non appaiono ravvisabili in concreto. Infatti, le funzioni proprie della professione docente - ricoperta dal ricorrente – non possono evidentemente ritenersi funzioni di interesse nazionale; neppure può ritenersi che a quella figura sia collegato l’esercizio di pubblici poteri, se non con riferimento ad alcune attività riconducibili a tale professione. Infatti, pur nella difficoltà di determinare la nozione di pubblici poteri, deve ritenersi che tale concetto indichi un potere esercitato da entità pubbliche per l’interesse generale dello Stato: ora, appare evidente come l’attività di insegnamento non integri i requisiti prospettati.
Neppure può condividersi la tesi di una sorta di “riserva di posti” a favore di cittadini italiani e/o comunitari, coerente e compatibile con la normativa nazionale e comunitaria vigente. Invero, la disciplina comunitaria nel suo complesso è orientata a eliminare tutti gli ostacoli alla libera circolazione dei lavoratori in ambito europeo, rimovendo limiti e vincoli burocratici e normativi, ma non può essere certamente interpretata come una sorta di patto di esclusione. La finalità di escludere tutti i lavoratori non appartenenti a Stati membri dell’U.E. - che deriverebbe dalla interpretazione proposta – non solo non è rinvenibile in alcuna disposizione comunitaria, ma appare apertamente in conflitto con i principi generali transnazionali su cui si fondano tutte le norme di integrazione a livello comunitario.
Da tanto il Tribunale conclude che l’esclusione dalla graduatoria del ricorrente debba ritenersi condotta discriminatoria con conseguente accoglimento del ricorso e condanna del Ministero ad adottare tutti gli atti necessari a consentire il suo inserimento, senza alcuna riserva con riferimento al requisito della cittadinanza, nella graduatoria di spettanza.
Anna Nardone
Pubblicato su “Il Sole 24 Ore Scuola” n. 15 del 17 - 30 settembre 2010
Commento giurisprudenziale
SECONDO LAVORO, SENZA L’OK SI RISCHIA IL LICENZIAMENTO
(Il versamento delle cifre incassate per attività non autorizzate non ha natura sanzionatoria)
Svolgere una seconda attività senza autorizzazione può costare il posto di lavoro. Inoltre, l'obbligo di versamento all’amministrazione di appartenenza del compenso dovuto per prestazioni svolte in dispregio del divieto dei dipendenti pubblici di svolgere incarichi retribuiti che non siano stati autorizzati, non ha natura di sanzione disciplinare e non necessita di una previa autonoma contestazione.
Infatti la legge prevede, nella specie, la sussistenza di una autonoma responsabilità disciplinare e di conseguenti sanzioni a carico del dipendente, il che porta ad escludere che l'obbligo di versamento del compenso dovuto per le prestazioni svolte in violazione del divieto sia esso stesso configurabile come sanzione disciplinare; oltre a ciò, la stessa legge impone l’obbligo di tale versamento in primis all'erogante (ossia a un soggetto estraneo al rapporto lavorativo) e, solo in difetto, al lavoratore che lo ha percepito. Così decide la Corte di Cassazione, sezione lavoro, con sentenza del 26 marzo 2010, n. 7343.
Peraltro, la medesima Cassazione, in altra precedente pronuncia, ha avuto occasione di chiarire che neppure il licenziamento intimato al dipendente che si trovi in situazione di incompatibilità ha natura sanzionatoria o disciplinare, essendo una mera diretta conseguenza della perdita di quei requisiti di indipendenza e di totale disponibilità che, se fossero mancati "ab origine", avrebbero precluso la stessa costituzione del rapporto di lavoro. Infatti, in materia di pubblico impiego, la disciplina dell'incompatibilità prevede che l'impiegato che si trovi in situazione di incompatibilità venga diffidato a cessare da tale situazione e che, decorsi quindici giorni dalla diffida, decada dall'incarico (Cass. civ. Sez. lavoro, 21 agosto 2009, n. 18608.)
La vicenda
Un dipendente pubblico impugnava il licenziamento intimatogli per avere espletato attività senza autorizzazione, siccome negatagli dall’Amministrazione, sul rilievo che il diniego era intervenuto quando ormai era decorso il termine di 30 giorni dalla richiesta di autorizzazione, onde su quest'ultima si era formato il silenzio assenso e, per conseguenza, i successivi provvedimenti dell'Amministrazione dovevano considerarsi illegittimi.
La Corte di Cassazione, definitivamente pronunciando, accoglie le ragioni dell’Amministrazione, sotto il profilo della legittimità del recesso e della condanna del dipendente al pagamento di quanto percepito per effetto dell'attività non autorizzata, conseguenza automatica dall'accertata illegittimità del comportamento del lavoratore e non autonoma sanzione disciplinare soggetta alle procedure conciliative.
Motivi della decisione
La Cassazione in via preliminare confuta l’asserzione del dipendente secondo cui gli atti della pubblica amministrazione datrice di lavoro concernenti il regime della incompatibilità avevano assunto natura di atti negoziali solo a partire dalle modifiche introdotte nel 1998, con la conseguenza che il silenzio assenso formatosi sull'istanza di autorizzazione avrebbe dovuto essere prima rimossa dall’Amministrazione, e, in difetto di ciò, il diniego opposto doveva ritenersi illegittimo, al pari del licenziamento, siccome fondato su tale provvedimento negativo.
Osserva la Corte che, già con l'emanazione del testo unico del pubblico impiego del 1993, il rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici era stato attratto nell'orbita della disciplina civilistica per tutti quei profili non connessi al momento esclusivamente pubblico dell'azione amministrativa (cfr, Corte Costituzionale n. 309/2007), con la conseguenza che gli atti di gestione del rapporto lavorativo privatizzato restavano esclusi dalla disciplina propria dell'atto amministrativo, dovendo essere invece posti in essere con i poteri de privato datore di lavoro; con la conseguenza che in tema di incompatibilità, già nella vigenza del predetto testo unico, l'attività datoriale in relazione al rapporto di lavoro privatizzato, pur restando regolata dalla specifica disciplina disposta ex lege, non veniva più ad esplicarsi attraverso provvedimenti amministrativi, bensì restava nell'ambito dei comportamenti di gestione del rapporto di lavoro (cfr, Cass., nn. 967/2006; 18608/2009).
Da tanto deriva la piena legittimità del licenziamento motivato dalla violazione dei principi di incompatibilità e indipendenza, sottesi alla norma che preclude la prestazione di attività non previamente autorizzate.
Il Giudice risolve poi l’eccezione del ricorrente fondata sull'assunto che l’amministrazione avrebbe richiesto le somme percepite per l’incarico contestato a titolo di sanzione disciplinare senza alcuna contestazione, limitandosi ad affermare che il versamento di tali somme costituiva conseguenza automatica dell'accertata illegittimità del comportamento del lavoratore.
La Corte rileva che secondo il citato testo unico "I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. (...) In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalente”. L'affermato autonomo rilievo della responsabilità disciplinare ("ferma restando la responsabilità disciplinare") porta ad escludere, già sotto l'aspetto strettamente testuale, che l'obbligo di versamento del compenso dovuto per le prestazioni svolte in dispregio del divieto sia configurabile, come pretende il ricorrente, quale sanzione disciplinare; il che resta poi confermato dal fatto che l'obbligo di tale versamento è imposto in primis all'erogante (ossia a un soggetto estraneo al rapporto lavorativo) e, solo in difetto, al lavoratore che lo ha percepito.
Ne consegue che la richiesta di versamento dei compensi non necessita di una previa autonoma contestazione disciplinare ed è pienamente legittima.
Anna Nardone
Pubblicato su “Il Sole 24 Ore Scuola” n. 14 del 3 - 16 settembre 2010
Commento giurisprudenziale
IL PROF CHE FALSIFICA I TITOLI CONDANNATO A RISARCIRE
(Dovrà restituire lo stipendio complessivo incassato per l’intera durata degli incarichi)
Il docente che abbia dichiarato falsamente il possesso di un titolo, ed abbia perciò ottenuto incarichi di insegnamento, è tenuto a risarcire l’amministrazione scolastica del danno risentito, quantificato in misura pari agli emolumenti corrisposti per tutta la durata degli incarichi. Così decide la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana, con sentenza del 23.04.2010 n. 127.
La vicenda
L’insegnate in questione aveva falsamente dichiarato - nella domanda per essere inclusa nella graduatoria permanente provinciale per il conseguimento di incarichi a tempo determinato ed indeterminato, e negli elenchi dei docenti di sostegno - di aver conseguito il diploma di specializzazione polivalente. In virtù dell’utile collocazione in graduatoria così ottenuta, era nominata quale insegnante di sostegno per ben cinque anni scolastici consecutivi. La Procura regionale siciliana reclamava il ristoro del danno dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in misura pari agli emolumenti corrisposti alla docente, e ne chiedeva la condanna al pagamento dei compensi percepiti in quegli anni.
La Corte dei Conti Siciliana – con sentenza di primo grado, confermata in appello – ha disposto la condanna della convenuta a pagare in favore del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca la somma corrispondente alle retribuzioni percepite per l’attività di insegnamento prestata senza il titolo falsamente dichiarato (pari a circa € 85.000,00).
Motivi della decisione
La Corte nega che nella specie possa sussistere alcuna utilità della prestazione comunque resa dall’insegnante.
La legge prevede, infatti, che il personale docente nelle classi delle scuole comuni che accolgono alunni portatori di handicap deve essere fornito di apposito titolo di specializzazione da conseguire al termine di un corso teorico-pratico di durata biennale presso scuole o istituti riconosciuti dal Ministero della pubblica istruzione. E’ vero che le stessa legge ammette l'utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei prescritti titoli di specializzazione, ma ciò è consentito unicamente qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati. La norma impone che i posti relativi al sostegno degli alunni portatori di handicap vengono coperti prioritariamente con personale specializzato, secondariamente con personale di ruolo che ne faccia domanda, ed infine con personale eventualmente in soprannumero.
Nessuno di tali presupposti risulta sussistente nella fattispecie e, d’altra parte, la falsificazione del titolo di specializzazione è avvenuta proprio perché l’insegnante non si trovava in alcuna delle condizioni previste dalla norma per essere legittimamente nominata.
Circa la presunta utilità che la prestazione resa dall’appellante avrebbe, comunque, prodotto alla scuola, ritiene, il Collegio che l’attività svolta dall’insegnante, proprio perché non collegata al possesso di un titolo di studio, che allo stato attuale della legislazione è requisito fondamentale ed indispensabile per l’attività dell’insegnamento di sostegno, non può avere recato alcun vantaggio.
In proposito, la giurisprudenza costante ha affermato che le prestazioni professionali svolte da un dipendente pubblico assunto illegittimamente su presentazione di falso titolo di studio, comportano un danno risarcibile per l’Amministrazione non operando al riguardo la compensazione del lucro con il danno, se non limitatamente alla quota di retribuzioni riconducibile a mansioni generiche e non professionalmente caratterizzate dal possesso di uno specifico titolo di studio e/o di specializzazione. Possono, quindi, essere legittimamente retribuite solo quelle attività lavorative che, per la loro assoluta genericità e fungibilità, non trovano un essenziale presupposto per un utile svolgimento nel possesso di conoscenze specialistiche.
Nel caso in esame, il possesso di requisiti professionali si pone come necessaria premessa per l'utile svolgimento dell’intera attività di insegnante di sostegno svolta dalla docente, cosicchè la mancanza del titolo di specializzazione esclude che anche solo una parte delle prestazioni rese possano essere in alcun modo compensate. Nella valutazione dell’assenza di utilità del lavoro svolto, occorre, altresì, considerare che l’attività fraudolenta posta in essere dall’interessata ha impedito che insegnanti maggiormente preparati potessero meglio sviluppare e sostenere l’integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap, violando così il loro diritto all'educazione e all'istruzione.
Rileva, infine, il Collegio che, al fine di giustificare il pagamento degli stipendi alla docente, neppure può farsi diretta applicazione dell'art. 2126 c.c., secondo cui la nullità o l’annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall’illiceità dell’oggetto o della causa.
Nella fattispecie, infatti, è stata raggiunta la prova che la percezione dei compensi è avvenuta in forza di atti illeciti di rilevanza penale ed è, quindi, esclusa la possibilità di riconoscere la spettanza di tali somme in favore della percipiente, a tutela di una ragionevole convinzione che le somme pagate le fossero realmente dovute.
La giurisprudenza costituzionale, peraltro, ha elaborato il principio per cui l'illiceità che priva il lavoro prestato della tutela collegata al relativo rapporto in seguito a nullità o annullamento del rapporto di lavoro, va ravvisata nel contrasto con norme fondamentali e generali o con i principi basilari dell'ordinamento; la stessa giurisprudenza è categorica nell'affermare che l'art. 36 Cost., presuppone un rapporto di lavoro lecitamente instaurato (Corte cost., sent. 14-19 giugno 1990, n. 296).
Orbene, nella fattispecie in giudizio ricorre sicuramente la violazione delle norme fondamentali del settore, cosicchè deve ritenersi radicalmente illecito, per illiceità della causa, il rapporto di lavoro costituito in violazione delle disposizioni in materia che costituiscono norme di ordine pubblico sociale.
Anna Nardone
Pubblicato su “Il Sole 24 Ore Scuola” n. 12 del 3 - 16 giugno 2010
Commento giurisprudenziale
IL TRASFERIMENTO SCATTA SE C’E’ INCOMPATIBILITA’
(Il provvedimento non ha carattere sanzionatorio né disciplinare. Motivazioni non obbligatorie)
Il trasferimento del dipendente per incompatibilità non ha carattere sanzionatorio nè natura disciplinare, e non postula un comportamento contrario ai doveri di ufficio, essendo subordinato ad una valutazione ampiamente discrezionale dei fatti, che possa far ritenere nociva per il prestigio, il decoro e la funzionalità dell’ufficio l’ulteriore permanenza del medesimo in una determinata sede. In particolare, nel trasferimento per ragioni di servizio, queste ben possono essere rivelate anche dal procedimento, risultando così attenuato il dovere dell’amministrazione di esternarne le ragioni. La funzione della motivazione, infatti, non viene meno per il fatto che nel provvedimento finale non risultino chiaramente e compiutamente esplicitate le ragioni sottese alle scelte discrezionali, allorché le stesse possano essere agevolmente colte dalla lettura degli atti attinenti al procedimento. Così ha deciso il Consiglio di Stato, sezione quarta, nella sentenza del 18 febbraio 2010, n. 944, confermando autorevolmente l’opinione di giurisprudenza che ritiene che sia assolto l’obbligo di motivazione altresì in presenza di un’illustrazione delle ragioni del provvedimento per relationem.
Vicenda e motivi della decisione
Il dipendente (invero, nella fattispecie, si trattava di un militare, ma i principi sono estendibili sostanziante anche agli altri impiegati pubblici) trasferito di sede in ragione di vicende personali aveva impugnato il provvedimento per violazione di legge e di procedimento, eccesso di potere sotto molteplici profili, difetto di motivazione. Il Consiglio di Stato, adito in secondo grado, ha ritenuto di respingere il ricorso del dipendente.
Il giudice dapprima richiama l’opinione consolidata della giurisprudenza secondo la quale la finalità del trasferimento di un dipendente pubblico per incompatibilità ambientale è quella di ripristinare il corretto e sereno funzionamento dell’ufficio, restituendo allo stesso il prestigio, l’autorevolezza o l’immagine perduti (cfr. Cons. Stato, sez. I, 8 maggio 2002, n. 870; Cons. Stato, sez. IV, 28 maggio 2003 n. 2970).
Conseguentemente un provvedimento di tale natura non è in alcun rapporto col provvedimento disciplinare eventualmente irrogato a carico del medesimo soggetto, in quanto il trasferimento si basa su una situazione oggettiva di disagio nell’ambiente di lavoro, mentre la sanzione disciplinare postula un criterio di imputazione della condotta illecita (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 29 agosto 2000, n. 4374; Cons. Stato n. 2970 del 2004 cit.). Il trasferimento per incompatibilità, infatti, non ha carattere sanzionatorio né postula un comportamento contrario ai doveri di ufficio, non ha, quindi, natura disciplinare, essendo subordinato ad una valutazione ampiamente discrezionale dei fatti, che possa far ritenere nociva per il prestigio, il decoro e la funzionalità dell’ufficio l’ulteriore permanenza del dipendente in una determinata sede (cfr. ex plurimis Cons. giust. amm., 28 gennaio 2003, n. 34; Cons. Stato, sez. I, 15 maggio 2002, n. 1382; Cons. Stato sez. VI, 16 maggio 1992, n. 387). In definitiva, non rileva tanto la responsabilità del soggetto i cui comportamenti hanno originato la situazione che incide negativamente sull’andamento complessivo dell’ufficio, quanto la sussistenza di uno o più episodi tali da compromettere il servizio stesso (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 29 marzo 2002, n. 1782; Cons. Stato, n. 2970 del 2004 cit.).
L’indagine fin qui svolta dal Consiglio di Stato sulla ratio, i presupposti legali e la natura del provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale consentono di pervenire a positive conclusioni in ordine al contenuto minimo motivazionale dell’atto in questione. In generale, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza, deve ritenersi assolto l’obbligo della motivazione del provvedimento amministrativo, anche in presenza di una motivazione succinta purchè capace di disvelare l’iter logico e procedimentale che consenta di inquadrare la fattispecie nell’ipotesi astratta considerata dalla legge (cfr. ex plurimis Cons. giust. amm., 20 gennaio 2003, n. 31; Cons. Stato, sez. VI, 18 novembre 1991, n. 874).
Anche la motivazione per relationem (con rimando, cioè, alle risultanze istruttorie) è comunemente ammessa alla luce dei principi generali di cui alla l. n. 241 del 1990, purchè: a) le ragioni dell’atto richiamato siano esaurienti – onde sia possibile desumere le ragioni in base alle quali la volontà dell’amministrazione si è determinata -; b) l’atto indicato al quale viene fatto riferimento, sia reso disponibile agli interessati; c) non vi siano pareri richiamati che siano in contrasto con altri pareri o determinazioni rese all’interno del medesimo procedimento (cfr. ex plurimis Cons. giust. amm., 20 gennaio 2003, n. 31; Cons Stato, sez. VI, 24 ottobre 1995, n. 1201; Cons. Stato, sez. IV, 7 marzo 1994, n. 204).
Con specifico riferimento al trasferimento per ragioni di servizio non si è mancato di affermare che queste ben possono essere rivelate anche dal procedimento, risultando così attenuato il dovere dell’amministrazione di esternarne le ragioni (cfr. sez. IV, 31 gennaio 2001, n. 550). La funzione della motivazione, infatti, non viene meno per il fatto che nel provvedimento finale non risultino chiaramente e compiutamente esplicitate le ragioni sottese alle scelte discrezionali, allorché le stesse possano essere agevolmente colte dalla lettura degli atti afferenti alle varie fasi in cui si articola il procedimento e ciò in forza di una considerazione non meramente formale dell’obbligo di motivazione, bensì coerente con i principi di trasparenza e di lealtà desumibili dall’art. 97 Cost. e dall’obbligo per l’amministrazione di improntare la propria azione a canoni di efficienza, economicità ed efficacia ex art. 1, l. n. 241 cit. (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 29 aprile 2002, n. 2281).
Nel caso di specie, nel provvedimento finale risultavano chiaramente e compiutamente esplicitate in motivazione le ragioni sottese alle scelte, attraverso il richiamo alle vicende personali del ricorrente, sotto il profilo dei riflessi negativi avevano causato all’immagine dell’amministrazione.
Anna Nardone
Pubblicato su “Il Sole 24 Ore Scuola” n. 10 del 13 – 26 maggio 2010
Commento giurisprudenziale
L’ACCESSO AI PARERI LEGALI NON VALE PER QUELLI SEGRETI
(Il diritto di visione è esercitabile solo nei confronti degli atti inseriti in procedimento amministrativo)
Il diritto di accesso è esercitabile nei confronti dei soli pareri legali - resi anche da professionisti esterni - che si inseriscono oggettivamente nell’ambito di un procedimento amministrativo, con esclusione dei pareri connessi con un procedimento contenzioso, posto che in tale evenienza il parere è da ritenersi coperto da segreto a tutela delle garanzie di difese riconosciute anche alle amministrazioni pubbliche. In altre parole, il discrimine tra l’accessibilità o meno al parere reso da un legale esterno o interno ad una amministrazione non è costituito dalla natura dell’atto, ma dalla funzione che svolge nell’attività dell’amministrazione stessa. Così ha deciso il TAR Liguria, con sentenza n. 3782 del 17 dicembre 2009, confermando un precedente orientamento del Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 2.4.2001, n. 1893).
La vicenda
Il ricorrente, professore universitario, chiedeva di accedere ai pareri che l’Ateneo di appartenenza aveva chiesto sia all’Ufficio legale interno che all’Avvocatura dello Stato al fine di dirimere una controversia sorta con il proprio docente.
Sennonché l’amministrazione rilasciava copia dei pareri prodotti con numerose omissioni che, a dire del ricorrente, ne rendevano impossibile la comprensione. Per quanto sopra il professore, dopo aver sollecitato l’esibizione integrale dei documenti, nella perdurante inerzia dell’ateneo, adiva il TAR con ricorso. Il docente fondava il proprio diritto di accesso sulla necessità di poter difendere i propri interessi giuridici; sulla impossibilità di sottrarre alla visione gli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere detti interessi giuridici; sulla circostanza che l’elenco degli atti esclusi per legge dall’accesso non comprendono la documentazione domandata dal professore, senza contare che la legge comunque lascia salva la prevalenza della necessità di conoscere anche quegli atti, per sé stessi generalmente inaccessibili, in caso di cura o difesa degli interessi giuridicamente rilevanti propri di coloro che ne fanno motivata richiesta.
Il Tribunale amministrativo adito respinge il ricorso del docente giudicando la sua pretese di accesso priva di fondamento.
Motivi della decisione
Il giudice richiama la più recente giurisprudenza amministrativa che ha più volte avuto modo di precisare come nell’ambito degli atti coperti da segreto, come tali sottratti per legge al diritto d’accesso, rientrino in linea generale gli atti redatti dai legali e dai professionisti in relazione a specifici rapporti di consulenza con l’amministrazione, in quanto detto segreto gode di una tutela qualificata, enucleata dalla disciplina dettata dalle norme codicistiche. Debbono quindi ritenersi accessibili i soli pareri resi, anche da professionisti esterni all’amministrazione, che si inseriscono nell’ambito di un’apposita istruttoria procedimentale, posto che in tale evenienza il parere è oggettivamene correlato ad un procedimento amministrativo, mentre debbono ritenersi coperti da segreto i pareri resi dopo l’avvio di un procedimento contenzioso (giudiziario, arbitrale, od anche meramente amministrativo), oppure dopo l’inizio di tipiche attività precontenziose (Consiglio Stato, Sezione V, 2 aprile 2001, n. 1893).
In particolare, il Consiglio di Stato osserva che il diritto di accesso affermato dalla legge 241 del 1990 non travolge le diverse ipotesi di segreti, previsti dall’ordinamento, finalizzati a tutelare interessi specifici, diversi da quello riconducibile, secondo l’impostazione più tradizionale, alla mera protezione dell’esercizio della funzione amministrativa. In tali eventualità, i documenti non sono suscettibili di divulgazione, perché il principio di trasparenza cede a fronte dell’esigenza di salvaguardare l’interesse protetto dalla normativa speciale sul segreto. Nell’ambito dei segreti sottratti all’accesso ai documenti rientrano gli atti redatti dai legali e dai professionisti in relazione a specifici rapporti di consulenza con l’amministrazione. Sono perciò sottratti all’accesso i seguenti documenti: pareri resi in relazione a lite in potenza o in atto e la inerente corrispondenza; atti defensionali. La giurisprudenza ha chiarito che detta regola ha una portata generale, e risponde, del resto, ad elementari considerazioni di salvaguardia della strategia processuale della parte, che non è tenuta a rivelare ad alcun soggetto e, tanto meno, al proprio contraddittore, attuale o potenziale, gli argomenti in base ai quali intende confutare le pretese avversarie.
In altri termini, ai fini dell’opposizione del segreto professionale alle istanze di accesso agli atti occorre distinguere fra pareri legali resi in relazione a contenziosi (sottratti al diritto di accesso) e pareri legali che rappresentano, anche per effetto di un richiamo esplicito nel provvedimento finale, un passaggio procedimentale istruttorio di un procedimento amministrativo in corso; solo il primo tipo di pareri, infatti, è sottratto all’accesso, in quanto non è la sola natura dell’atto a giustificare la segretezza, ma la funzione che l’atto stesso svolge nell’azione dell’amministrazione.
Il punto di discrimine tra l’accessibilità o meno del parere reso da un legale esterno o interno ad un ente, quindi, non è costituito dalla natura dell’atto, ma dalla sua funzione.
Se il parere viene reso in una fase endoprocedimentale, prodromica ad un provvedimento amministrativo, lo stesso è ammesso all’accesso, mentre se viene reso in una fase contenziosa o anche precontenziosa, l’accesso è escluso a tutela delle esigenze di difesa.
Tanto premesso, inserendosi in una fase contenziosa, i pareri legali in discussione nella specie non sono accessibili dal ricorrente, per cui questi non può dolersi, in radice, del fatto che essi gli siano stati consegnati in forma incompleta, dato che non sussisteva comunque alcun diritto a prenderne visione. Per le ragioni esposte, il TAR Liguria giudica il ricorso infondato, e come tale lo respinge.
Anna Nardone
Pubblicato su “Il Sole 24 Ore Scuola” n. 2 del 22 gennaio - 4 febbraio 2010
Commento giurisprudenziale
NO AD ATTI DI DEROGA DEL CONTRATTO PUBBLICO
(Per i dipendenti della Pa i criteri fanno riferimento solo al Ccnl e alle leggi sul privato)
Dopo la privatizzazione dei rapporti di lavoro pubblico, i medesimi sono regolati esclusivamente dai contratti collettivi e dalle leggi sul rapporto di lavoro privato, con esclusione di ogni potere del datore di lavoro pubblico di derogare alle disposizioni citate, neppure in meglio. Così hanno sentenziato le Sezioni Unite della Cassazione, evidenziando come in tali ipotesi l’atto assunto in deroga è nullo sia come atto negoziale, per violazione di norma imperativa, sia come atto amministrativo, perché viziato da difetto assoluto di attribuzione, escluso che la P.A. possa intervenire con atti autoritativi nelle materie demandate alla contrattazione collettiva (Cass., SSUU, 14.10.2009 n. 21744) .
Motivi della decisione
A parere della Cassazione deve escludersi in radice il potere del datore di lavoro pubblico di introdurre deroghe anche a favore dei dipendenti all’assetto definito in sede di contrattazione collettiva. SI tratta di uno dei principi cardine della riforma consistita nella contrattualizzazione del rapporto di lavoro pubblico, espresso in numerose disposizioni del testo unico sul pubblico impiego (d.lgs. n. 165/2001): i rapporti di lavoro sono regolati esclusivamente dai contratti collettivi e dalle leggi sul rapporto di lavoro privato; i contratti individuali possono incidere sui trattamenti economici definiti in sede collettiva solo se specificamente abilitati dalla legge; sul trattamento economico, interamente definito dai contratti collettivi, non può incidere il datore di lavoro in violazione del principio di parità di trattamento contrattuale (art. 45, commi 1 e 2); persino il potere legislativo – salvo che non introduca esplicitamente una clausola di salvaguardia – deve cedere di fronte alle disposizioni dei contratti collettivi in ambito normativo ed economico (art. 2 e art. 3). A quest’ultimo proposito, si è precisato che in materia di rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, l'efficacia derogatoria riconosciuta al contratto collettivo rispetto alla legge, presuppone che la legge della cui deroga si tratti non investa la fonte collettiva del compito della propria attuazione, poiché ove ciò accada viene meno il presupposto stesso di operatività della disciplina concernente la suddetta efficacia, senza che, a tal fine, sia anche necessario che la legge disponga espressamente la propria inderogabilità diversamente da quel che deve avvenire quando la legge non disponga in alcun modo circa i propri rapporti con successive norme di fonte collettiva (Cass. civ. Sez. lavoro, 23.9.2005, n. 18657). E ugualmente si puntualizza l'inapplicabilità delle norme legislative sul pubblico impiego, già vigenti al momento della stipulazione di contratti collettivi di contenuto contrario, salva – anche con riferimento alla legislazione futura - l'inderogabilità delle norme imperative, anche in assenza di espressa previsione legislativa.
Riconoscere al datore di lavoro pubblico il potere di derogare e/o violare le disposizioni della fonte collettiva significa con tutta evidenza contraddire le linee fondamentali dell’accennato sistema legislativo. Al datore di lavoro pubblico, infatti, il contratto collettivo riconosce soltanto la possibilità di adattare le indicazioni del contratto alle sue esigenza organizzative, senza modificare posizioni giuridiche ed economiche stabilite dalle norme pattizie.
L’atto in deroga, anche in meglio, alle disposizioni del contratto collettivo sarebbe quindi affetto in ogni caso da nullità, sia quale atto negoziale, per violazione di norma imperativa, sia quale atto amministrativo, perché viziato per difetto assoluto di attribuzione ai sensi dell’art. 21-septies della legge n. 241 del 1990 (l’ordinamento esclude che l’amministrazione possa intervenire con atti autoritativi nelle materie demandate alla contrattazione collettiva).
La stessa Corte Costituzionale ha avuto modo di evidenziare le peculiarità del contratto collettivo nel pubblico impiego, quali l’efficacia erga omnes, la sua funzionalità all'interesse pubblico di cui all’art. 97, Cost., l’inderogabilità sia in peius che in melius (C. Cost., 5.6.2003, n. 199). Il giudice delle leggi ha altresì specificato che l'applicazione del contratto collettivo di lavoro a tutti i pubblici dipendenti (erga omnes) deriva dal dovere gravante sulle pubbliche amministrazioni, tutte rappresentate, nella contrattazione collettiva, dall'Aran, di conformarsi, agli impegni assunti in sede negoziale. La forza cogente del contratto collettivo costituisce la premessa per realizzare la garanzia della parità di trattamento e d'inderogabilità dei livelli minimi fissati dai contratti collettivi. Sul versante della posizione soggettiva del dipendente pubblico, invece, l'applicazione del contratto collettivo nei suoi confronti deriva dal rinvio alla disciplina collettiva contenuto nel contratto individuale di lavoro, per effetto del quale il contratto collettivo diviene impegnativo per tutti i dipendenti. In altri termini, la prestazione e le condizioni contrattuali della stessa trovano la loro origine nell'avere il singolo dipendente accettato che il rapporto di lavoro si instauri (o prosegua) secondo regole definite, almeno in parte, nella sede della contrattazione collettiva (Corte cost., 16.10.1997, n. 309).
E ugualmente il Consiglio di Stato ha avuto occasione di precisare che in assenza di speciali e indicate condizioni legittimanti la previsione di condizioni contrattuali individuali difformi da quelle del contratto collettivo, le prime devono considerarsi affette da nullità per contrasto con norme da reputarsi inderogabili ai sensi del citato art. 97, Cost., con conseguente operatività del meccanismo di sostituzione automatica di cui all'art. 1339, c.c. (Cons. Stato, Sez. VI, 15.1.2002, n. 193); e così ha ritenuto che, alla luce di una interpretazione sistematica, anche nel disegno del testo unico del pubblico impiego, i trattamenti economici fissati dai contratti collettivi siano inderogabili anche "in melius" oltre che "in peius" (Cons. Stato Sez. IV, 15.9.1998, n. 1161).
Anna Nardone
Pubblicato su “Il Sole 24 Ore Scuola” n. 1 dell’8 - 21 gennaio 2010
VA RISARCITO L’INFORTUNIO DURANTE LA PAUSA PRANZO
E’ indennizzabile l’infortunio in itinere anche nell’ipotesi in cui il lavoratore sia tornato a casa per la pausa pranzo, usufruendo di un mezzo proprio, laddove il percorso seguito costituisce quello normale per recarsi al lavoro e per tornare alla propria abitazione, e sia seguito per motivi collegabili all’attività lavorativa, e non per ragioni personali o in orari non collegabili a detta attività; l’uso del veicolo privato per il collegamento tra abitazione e luogo di lavoro sia giustificato in considerazione della mancanza di trasporto pubblico ovvero dell’incompatibilità degli orari del trasporto pubblico rispetto all’orario di lavoro dell’infortunato; sia assente una mensa aziendale, ovvero – come nella specie - non offra quel particolare regime dietetico seguito da lavoratore, e che solo al proprio domicilio può seguire. Così decide la Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, con sentenza 27.05.2009, n. 12326, nella quale torna a pronunciarsi in materia di indennizzabilità degli infortuni in itinere, ribadendo i propri indirizzi ormai consolidati.
La vicenda
Un docente universitario veniva coinvolto in un incidente stradale in seguito al quale perdeva la vita, mentre si recava all’università su una moto che si scontrava con altra autovettura. Gli eredi ricorrenti ritenevano sussistere gli estremi dell’infortunio in itinere in quanto il professore era obbligato a recarsi a casa per consumare il pasto essendo affetto da varie patologie e non avendo l’università una mensa: pertanto richiedevano il riconoscimento dell’infortunio in itinere con diritto alla rendita vitalizia e la condanna dell’INAIL al risarcimento del danno biologico. La Cassazione, definitivamente pronunciando, giudica sussistenti nella specie tutti i presupposti per il riconoscimento dell’infortunio in itinere meritevole di indennizzo.
Motivi della decisione
La Cassazione ribadisce il proprio consolidato indirizzo secondo cui un infortunio occorso a un lavoratore può ritenersi verificato in occasione di lavoro e, in quanto tale, tutelato dalle specifiche norme di protezione antinfortunistiche, allorchè sussista uno specifico collegamento tra l’evento lesivo e l’attività lavorativa. In particolare, ai fini dell’indennizzabilità dell’infortunio in itinere, anche in caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato deve aversi riguardo ai criteri che individuino la legittimità o meno dell’uso del mezzo in questione secondo gli «standars» comportamentali esistenti nella società civile e rispondenti ad esigenze tutelate dall’ordinamento, quali un più intenso legame con la comunità familiare ed un rapporto con l’attività lavorativa diretto ad una maggiore efficienza delle prestazioni (cfr. Cass. Sez. lav., 23 maggio 2008, n. 13376; Cass. sez. lav. 27 gennaio 2006. n. 1712; Cass., sez. lav., 4 aprile 2005. n. 6929). L’indennizzabilità dell’infortunio subito dal lavoratore neI percorrere, con mezzo privato la distanza fra la sua abitazione ed il luogo di lavoro, postula: a) la sussistenza di un nesso eziologico tra il percorso seguito e l’evento, nel senso che tale percorso deve costituire per l’infortunato quello normale per recarsi al lavoro e per tornare alla propria abitazione: b) la sussistenza di un nesso almeno occasionale tra itinerario seguito ed attività lavorativa, nel senso che il primo non sia dal lavoratore percorso per ragioni personali o in orari non collegabili alla seconda; c) la necessità dell’uso del veicolo privato, adoperato dal lavoratore, per il collegamento tra abitazione e luogo di lavoro, da accertarsi in considerazione della compatibilità degli orari dei pubblici servizi di trasporto rispetto all’orario di lavoro dell’assicurato, ovvero della sicura fruibilità dei pubblici servizi di trasporto qualora risulti impossibile, tenuto conto delle peculiarità dell’attività svolta, la previa determinazione della durata della sua prestazione lavorativa. Presupposti questi la cui sussistenza è stata verificata nel caso di specie: l’infortunio avveniva allorché il docente veniva coinvolto in un incidente stradale per essere stata la sua moto investita da una autovettura; nell’incidente il professore perdeva la vita. Veniva accertato che il professore aveva necessità di rientrare presso la propria abitazione per il pranzo, seguendo egli un particolare regime dietetico che solo al proprio domicilio poteva essere scrupolosamente seguito; che, inoltre, l’orario in cui si era verificato l’incidente era e compatibile con quello di normale consumazione dei pasti; in ordine poi al carattere necessitato della scelta del mezzo, veniva considerato che nel periodo estivo – di cui era causa - il servizio pubblico di trasporto cittadino diradava i propri orari talché il mezzo privato diventava “una vera e propria necessità.
In tema di infortunio in itinere, un orientamento della giurisprudenza nega la tutela al dipendente pubblico vittima di un sinistro verificatosi nel tragitto casa-lavoro con mezzo proprio, allorché risulti che la responsabilità dell'incidente sia a lui imputabile. Infatti si ritiene che la violazione del codice della strada può integrare un aggravamento del rischio tutelato talmente esorbitante dalle finalità di tutela da escludere la stessa in radice (cfr. Cass. Sez. Lav. 6.8.2003 n. 11885; Cons. Stato, Sez. VI, 20.3.2007 n. 1309). Un opposto indirizzo della Cassazione afferma invece il principio di diritto secondo il quale la colpa esclusiva del lavoratore non osta all’indennizzabilità dell’infortunio in itinere, salvo il limite del "rischio elettivo", inteso quale scelta di un comportamento abnorme, volontario e arbitrario da parte del lavoratore tale da condurlo ad affrontare rischi diversi da quelli inerenti alla normale attività. E proprio in riferimento ad un infortunio in itinere occorso ad un lavoratore che aveva provocato un incidente per non aver osservato il codice della strada, la Cassazione giudicava che neanche l'addebitabilità dell'incidente alla violazione di una specifica prescrizione è idonea, di per sè, a configurare l'ipotesi del rischio elettivo (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro, 4.12.2001, n. 15312).
Anna Nardone
Pubblicato su “ Il Sole 24 Ore Scuola” n. 13 del 25 giu. – 27 ago. 2009
Maternità
SE IL PARTO E’ GEMELLARE NON E’ DOPPIO CONGEDO
In caso di parto plurimo, alla docente non spetta la moltiplicazione del periodo di congedo parentale (già astensione facoltativa dal lavoro per maternità) con retribuzione intera in conformità alle previsioni della contrattazione collettiva di comparto. Così decide il Tribunale del Lavoro di Modena, con sentenza 584/2008.
La vicenda
Una docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato era divenuta madre di due gemelle. Terminato il periodo di congedo di maternità obbligatoria, la ricorrente aveva chiesto all'amministrazione scolastica di poter usufruire di un periodo di congedo parentale (già astensione facoltativa) di un mese per un prima figlia; di un altro mese per l’altra figlia, entrambi con una retribuzione al 100%, come previsto dalla contrattazione collettiva di settore. Tale beneficio veniva inizialmente accordato dalla scuola di servizio, tuttavia, a seguito di rilievo della Ragioneria Provinciale dello Stato, l'amministrazione scolastica provvedeva a recuperare il 70% della retribuzione. Non condividendo tale posizione, la ricorrente si rivolgeva al giudice del lavoro. Deduceva quest'ultima che l'articolo 32 del testo unico 151/2001 disponeva il diritto ai congedi parentali per ogni figlio, nei suoi primi otto anni di vita, sicché il lavoratore dipendente aveva diritto alla moltiplicazione dei periodi di astensione facoltativa in relazione al numero dei figli, anche se gemelli, e l'articolo 12 del contratto collettivo per la scuola sanciva l'applicabilità al personale della scuola delle vigenti disposizioni in materia di congedi parentali, di più stabilendo che i primi 30 giorni di congedo parentale siano retribuiti nella misura del 100% della retribuzione. Ritenendo che a fronte della duplicazione dei congedi parentali l'articolo 12 del CCNL della scuola potesse consentire la duplicazione anche dei benefici retributivi, la ricorrente chiedeva due mesi di astensione facoltativa al 100% dello stipendio, uno per ciascuna figlia. Il Tribunale di Modena ritiene di rigettare l'istanza della ricorrente.
Motivi della decisione
Osserva il giudice adito che l'articolo 32 del d.lgs. 151 / 2001 stabilisce che "per ogni bambino, nei primi suoi otto anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo […] il diritto di astenersi dal lavoro compete: a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al capo III, per un periodo continuativo frazionato non superiore a sei mesi”. L'articolo 34 prevede poi che "per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta sino al terzo anno di vita del bambino, un'indennità pari al 30% della retribuzione". Le norme di cui sopra disciplinano sia il periodo di congedo parentale che compete dopo la nascita dei figli, sia il relativo trattamento economico che compete durante il periodo di congedo parentale. Tali norme prendono anche in considerazione l'ipotesi di parto plurimo (l’articolo 32: "per ogni bambino..."; l’articolo 34: "per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32..." ). A sua volta, il contratto collettivo del comparto scuola prevede una disciplina più favorevole, per il trattamento economico, rispetto alla disciplina valida per tutti i lavoratori pubblici e privati prevista dal d.lgs. 151/2001. In particolare, l'articolo 12 CCNL dispone che "nell'ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall'articolo 32, comma uno, lettera a) del D.lgs n. 151/2001, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi 30 giorni […] non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio e sono retribuiti per intero". Tale norma, facendo riferimento all'articolo 32 del d.lgs n. 151/2001 già ricomprende l'ipotesi (prevista e disciplinata da detto articolo) di parto plurimo, stabilendo che nel periodo di fruizione del congedo facoltativo i primi 30 giorni sono retribuiti per intero. Ove la norma contrattuale avesse voluto disporre una moltiplicazione o comunque un aumento della parte del periodo di congedo retribuito per intero in relazione al numero dei figli non avrebbe mancato di specificare tale diritto del lavoratore. Ciò è del resto avvenuto per i periodi di riposo: infatti una apposita norma prevede espressamente che in caso di parto plurimo i periodi di riposo sono raddoppiati: ciò significa che in caso di nascita di due o più figli le ore di riposo spettanti sono il doppio rispetto all'ipotesi di parto singolo. A contrario – conclude il Tribunale di Modena – alla docente ricorrente compete il pagamento dell'intera retribuzione per i primi 30 giorni del fruito periodo di congedo parentale e, in forza del richiamo operato dal comma 1 dell'articolo 12 del menzionato CCNL, per il periodo successivo compete il pagamento del 30% della retribuzione. Si da atto che lo stesso organo giudicante, infine, ammette l’opinabilità della materia di cui è causa. A tale proposito, giova ricordare che la giurisprudenza è unanime nel giudicare che i periodi di congedo parentale – già astensione facoltativa dal lavoro per maternità – al pari di quelli di astensione obbligatoria, devono essere computati a tutti gli effetti nell'anzianità di servizio del dipendente pubblico. Infatti, la circostanza che l'astensione facoltativa si ponga per definizione come frutto di libera scelta dell'interessata non toglie, infatti, che la medesima sia rivolta alla tutela della prole, ossia al soddisfacimento di esigenze intimamente compenetrate con la tutela della maternità naturale posta a fondamento dell'astensione obbligatoria - in un'ottica di naturale continuazione. Così si conferma l’equiparazione del congedo parentale- astensione facoltativa all'effettiva prestazione di servizio, salvo che ai fini delle ferie, della tredicesima mensilità e della gratifica natalizia (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 13.11.2007 n. 5797; Cons. Stato, sez. VI, 26.4.2002, n. 2254; Cons. Stato, sez. VI, 9.4.2000, n. 2038; Cons. Stato, sez. II, parere 17.10.1990; Cons. Stato, sez. VI, 16.5.2001, n. 2760).
Anna Nardone
Pubblicato su “ Il Sole 24 Ore Scuola” n. 11 del 29 mag. – 11 giu. 2009