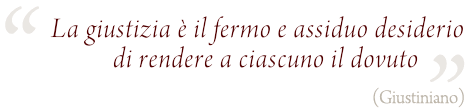Rapporto di lavoro
GIUDICI D’ACCORDO SULL’ASSEGNO
(Interpretazione convergente tra i magistrati della Corte dei conti)
Il diritto del pensionato pubblico all’applicazione degli aumenti secondo il coefficiente ISTAT calcolato su una IIS “teorica” intera, invece che su quella effettiva, decurtata in quarantesimi, a decorrere dalla data del raggiungimento dell'età pensionabile, è riconosciuto dalla giurisprudenza prevalente (si vedano da ultimo le recentissime decisioni Corte dei Conti per la Lombardia del 19 aprile 2010, favorevoli a dichiarare il diritto all’applicazione del citato meccanismo perequativo).
A tale proposito, e a titolo esemplificativo, si legga quanto correttamente esplicato in una precedente sentenza della Corte dei Conti Lombardia 393 del 2006: “Ai soli fini del calcolo della quota di incremento della pensione concettualmente riferibile alla perequazione della I.I.S. - e ferma restando la corresponsione in quarantesimi della I.I.S. effettivamente in godimento, alla quale l'aumento “intero” va a sommarsi - deve considerarsi una I.I.S. fittiziamente calcolata nella intera misura. Inoltre, tenuto conto della ratio della norma, che è quella di omogeneizzare gli incrementi per tutti i pensionati di una certa età - si rammenta che per “misura intera” deve intendersi non tanto l'ammontare dell'I.I.S. corrente alla data del pensionamento (I.I.S. storica), bensì l'importo attualizzato al periodo di riferimento della perequazione (comprensivo, cioè, delle variazioni medio tempore intervenute sulla I.I.S. “piena”).
Ugualmente concorde è l’opinione dei giudici delle pensioni sulla circostanza che i successivi criteri introdotti per il calcolo della perequazione automatica non abbiano innovato sul vigente sistema di adeguamento dell'IIS sancito dall'articolo 10 del decreto legge 17 del 1983, specie in ragione della finalità della norma che era quella di riconoscere ai pensionati “anticipati”, una volta compiuta l’età dovuta, un aumento dell’i.i.s. pari a quello spettante agli altri pensionati. L’interpretazioni illustrata, sostenuta dalla giurisprudenza maggioritaria, è altresì idonea a salvaguardare le ragioni di fondo sottese alla stessa riduzione dell'IIS in quarantesimi poiché, in ogni caso, la quantificazione dell'IIS percepita dai titolari di pensione di anzianità rimane comunque inferiore alla misura prevista per i pensionati cessati al raggiungimento del limite d'età, trovando ciò razionale giustificazione nella diversità sostanziale tra le posizioni soggettive sottostanti.
Ancora più chiara si propone la decisione 27/2006 della Corte dei Conti Piemonte: “ai soli fini del calcolo della quota di incremento della pensione concettualmente riferibile alla perequazione della i.i.s., e ferma restando la corresponsione in quarantesimi della i.i.s. effettivamente in godimento (alla quale l’aumento “intero” va a sommarsi), deve riconoscersi al pensionato (verificandosi le condizioni di cui al quarto comma, citato) una perequazione periodica calcolata sulla pensione comprensiva non già della i.i.s. “effettiva” in pagamento, bensì di una i.i.s. fittiziamente riconosciutagli nella intera misura. Inoltre, tenuto conto della ratio della norma, come sopra ricostruita, per “misura intera” deve intendersi non tanto quella storica, riferita alla i.i.s. corrente alla data del pensionamento, quanto quella attualizzata al periodo oggetto di perequazione (cioè comprensiva delle variazioni nel frattempo intervenute sulla i.i.s. “piena”). L’effetto pratico di questa interpretazione consiste nel riconoscere al pensionato, compiuta l’età prevista, un incremento periodico sulla i.i.s. (appunto: la sola “variazione”) pari a quello che gli sarebbe corrisposto se l’i.i.s. gli fosse stata concessa ab origine nella misura intera; così operando, l’incremento della i.i.s. è reso pari, tempo per tempo, a quello corrisposto a chi era andato in quiescenza con il massimo dell’anzianità; lo stesso beneficio è in tal modo conservato nel “nuovo” sistema della perequazione automatica esattamente come in quello “vecchio” del valore unitario del punto di contingenza, ferma restando l’i.i.s. “effettiva” in pagamento (che resta ragguagliata ai “quarantesimi”)”.
Domenico Barboni
Pubblicato su “Il Sole 24 Ore Scuola” n. 10 del 13 – 26 maggio 2010
Commento giurisprudenziale
NON E’ LECITA L’ESCLUSIONE DEL PROF NON COMUNITARIO
(di segno opposto altre decisioni della Cassazione che giustificano l’estromissione dei supplenti dalle liste)
E’ discriminatoria la condotta dell’amministrazione che esclude un docente extracomunitario dalla graduatoria degli aspiranti ad incarichi di docenza. sulla base del solo difetto del requisito della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’U.E. Così decide il Giudice del lavoro di Milano, ordinando alla medesima amministrazione di inserire il docente ad ogni effetto nella graduatoria di spettanza, senza alcuna riserva relativamente al requisito della cittadinanza (Ordinanza 11.1.2010).
La pronuncia assume una posizione per nulla pacifica in giurisprudenza, state le decisioni di segno opposto pure della Cassazione, che giustificano - anche sotto il profilo costituzionale - l’esclusione dello straniero non comunitario dall’accesso al lavoro pubblico, al di fuori di eccezioni espressamente previste dalla legge (Cass. 13.11.2006 n. 24170).
La vicenda
Il ricorrente, di nazionalità canadese, regolarmente residente in Italia, presentava domanda per l’inserimento nella graduatoria degli aspiranti ad incarichi di docenza. Ritenuto in possesso dei requisiti e titoli richiesti dalle norme vigenti, il medesimo veniva regolarmente inserito nella graduatoria con il punteggio di spettanza, e quindi incaricato dall’amministrazione in qualità di supplente. Sennonché, la nomina veniva poco dopo annullata perché il docente era ritenuto non in possesso del requisito della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’U.E. Il docente proponeva ricorso al giudice del lavoro domandando l’accertamento della natura discriminatoria del comportamento tenuto dall’amministrazione e l’ordine di cessazione del medesimo comportamento pregiudizievole. Il giudice adito ha accertato la natura discriminatoria e lesiva della condotta dell’amministrazione e condannato il Ministero ad inserire il docente nella graduatoria a tutti gli effetti di legge.
Motivi della decisione
Il Tribunale del Lavoro prende le mosse dal quadro normativo nazionale e comunitario di riferimento, chiaramente orientato a sostenere il principio di uguaglianza e parità di trattamento fra cittadini extracomunitari e cittadini italiani, tendendo a rimuovere tutti gli ostacoli destinati a frapporsi al perseguimento della finalità generale. A tal proposito fa riferimento all’articolo 3 della Costituzione che fissa il principio generale di uguaglianza riferibile anche ai non cittadini; e alle norme interne e internazionali ratificate che impegnano l’ordinamento a promuovere e garantire la parità di opportunità di trattamento in materia di occupazione e professione per le persone che si trovino regolarmente sul territorio.
Posto il quadro normativo di riferimento, il fine del perseguimento della tutela del lavoratore extracomunitario e della parità di trattamento deve ritenersi non ostacolato dalla natura “pubblica” del datore di lavoro. L’accesso degli stranieri alle dipendenze della PA oltre ad essere stato in più occasioni riconosciuto dalla giurisprudenza, trova anche supporto normativo in una serie di disposizioni (con riferimento a infermieri professionali, professori universitari e ricercatori; rifugiati).
Sotto questo profilo, una condotta come quella di specie – altrimenti discriminatoria - potrebbe essere giustificata solo da norme di rango superiore e/o derogatorie rispetto al quadro normativo su prospettato. Ed invero vi sono disposizioni che escludono l’accesso di stranieri a posti della PA che implichino l‘esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero attengano alla tutela dell’interesse nazionale.
Orbene, secondo il giudice, tenendo conto proprio dell’evoluzione normativa nazionale e internazionale in materia - che appare inevitabilmente e chiaramente indirizzata a parificare le posizioni di tutti gli individui sul mercato del lavoro - il principio generale deve essere quello dell’assenza di una qualsiasi ingiustificata differenziazione tra il cittadino italiano e straniero nell’accesso al lavoro, con il solo limite dello svolgimento di determinate attività che comportino l’esercizio di pubblici poteri o di funzioni di interesse nazionale. Tale ipotesi, che certamente legittimerebbe il trattamento differenziato, devono ritenersi - a parare del giudice – insussistenti nel caso di specie non solo perchè difetta una espressa previsione normativa, ma perchè tali requisiti non appaiono ravvisabili in concreto. Infatti, le funzioni proprie della professione docente - ricoperta dal ricorrente – non possono evidentemente ritenersi funzioni di interesse nazionale; neppure può ritenersi che a quella figura sia collegato l’esercizio di pubblici poteri, se non con riferimento ad alcune attività riconducibili a tale professione. Infatti, pur nella difficoltà di determinare la nozione di pubblici poteri, deve ritenersi che tale concetto indichi un potere esercitato da entità pubbliche per l’interesse generale dello Stato: ora, appare evidente come l’attività di insegnamento non integri i requisiti prospettati.
Neppure può condividersi la tesi di una sorta di “riserva di posti” a favore di cittadini italiani e/o comunitari, coerente e compatibile con la normativa nazionale e comunitaria vigente. Invero, la disciplina comunitaria nel suo complesso è orientata a eliminare tutti gli ostacoli alla libera circolazione dei lavoratori in ambito europeo, rimovendo limiti e vincoli burocratici e normativi, ma non può essere certamente interpretata come una sorta di patto di esclusione. La finalità di escludere tutti i lavoratori non appartenenti a Stati membri dell’U.E. - che deriverebbe dalla interpretazione proposta – non solo non è rinvenibile in alcuna disposizione comunitaria, ma appare apertamente in conflitto con i principi generali transnazionali su cui si fondano tutte le norme di integrazione a livello comunitario.
Da tanto il Tribunale conclude che l’esclusione dalla graduatoria del ricorrente debba ritenersi condotta discriminatoria con conseguente accoglimento del ricorso e condanna del Ministero ad adottare tutti gli atti necessari a consentire il suo inserimento, senza alcuna riserva con riferimento al requisito della cittadinanza, nella graduatoria di spettanza.
Anna Nardone
Pubblicato su “Il Sole 24 Ore Scuola” n. 15 del 17 - 30 settembre 2010
Commento giurisprudenziale
IL PROF CHE FALSIFICA I TITOLI CONDANNATO A RISARCIRE
(Dovrà restituire lo stipendio complessivo incassato per l’intera durata degli incarichi)
Il docente che abbia dichiarato falsamente il possesso di un titolo, ed abbia perciò ottenuto incarichi di insegnamento, è tenuto a risarcire l’amministrazione scolastica del danno risentito, quantificato in misura pari agli emolumenti corrisposti per tutta la durata degli incarichi. Così decide la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana, con sentenza del 23.04.2010 n. 127.
La vicenda
L’insegnate in questione aveva falsamente dichiarato - nella domanda per essere inclusa nella graduatoria permanente provinciale per il conseguimento di incarichi a tempo determinato ed indeterminato, e negli elenchi dei docenti di sostegno - di aver conseguito il diploma di specializzazione polivalente. In virtù dell’utile collocazione in graduatoria così ottenuta, era nominata quale insegnante di sostegno per ben cinque anni scolastici consecutivi. La Procura regionale siciliana reclamava il ristoro del danno dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in misura pari agli emolumenti corrisposti alla docente, e ne chiedeva la condanna al pagamento dei compensi percepiti in quegli anni.
La Corte dei Conti Siciliana – con sentenza di primo grado, confermata in appello – ha disposto la condanna della convenuta a pagare in favore del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca la somma corrispondente alle retribuzioni percepite per l’attività di insegnamento prestata senza il titolo falsamente dichiarato (pari a circa € 85.000,00).
Motivi della decisione
La Corte nega che nella specie possa sussistere alcuna utilità della prestazione comunque resa dall’insegnante.
La legge prevede, infatti, che il personale docente nelle classi delle scuole comuni che accolgono alunni portatori di handicap deve essere fornito di apposito titolo di specializzazione da conseguire al termine di un corso teorico-pratico di durata biennale presso scuole o istituti riconosciuti dal Ministero della pubblica istruzione. E’ vero che le stessa legge ammette l'utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei prescritti titoli di specializzazione, ma ciò è consentito unicamente qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati. La norma impone che i posti relativi al sostegno degli alunni portatori di handicap vengono coperti prioritariamente con personale specializzato, secondariamente con personale di ruolo che ne faccia domanda, ed infine con personale eventualmente in soprannumero.
Nessuno di tali presupposti risulta sussistente nella fattispecie e, d’altra parte, la falsificazione del titolo di specializzazione è avvenuta proprio perché l’insegnante non si trovava in alcuna delle condizioni previste dalla norma per essere legittimamente nominata.
Circa la presunta utilità che la prestazione resa dall’appellante avrebbe, comunque, prodotto alla scuola, ritiene, il Collegio che l’attività svolta dall’insegnante, proprio perché non collegata al possesso di un titolo di studio, che allo stato attuale della legislazione è requisito fondamentale ed indispensabile per l’attività dell’insegnamento di sostegno, non può avere recato alcun vantaggio.
In proposito, la giurisprudenza costante ha affermato che le prestazioni professionali svolte da un dipendente pubblico assunto illegittimamente su presentazione di falso titolo di studio, comportano un danno risarcibile per l’Amministrazione non operando al riguardo la compensazione del lucro con il danno, se non limitatamente alla quota di retribuzioni riconducibile a mansioni generiche e non professionalmente caratterizzate dal possesso di uno specifico titolo di studio e/o di specializzazione. Possono, quindi, essere legittimamente retribuite solo quelle attività lavorative che, per la loro assoluta genericità e fungibilità, non trovano un essenziale presupposto per un utile svolgimento nel possesso di conoscenze specialistiche.
Nel caso in esame, il possesso di requisiti professionali si pone come necessaria premessa per l'utile svolgimento dell’intera attività di insegnante di sostegno svolta dalla docente, cosicchè la mancanza del titolo di specializzazione esclude che anche solo una parte delle prestazioni rese possano essere in alcun modo compensate. Nella valutazione dell’assenza di utilità del lavoro svolto, occorre, altresì, considerare che l’attività fraudolenta posta in essere dall’interessata ha impedito che insegnanti maggiormente preparati potessero meglio sviluppare e sostenere l’integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap, violando così il loro diritto all'educazione e all'istruzione.
Rileva, infine, il Collegio che, al fine di giustificare il pagamento degli stipendi alla docente, neppure può farsi diretta applicazione dell'art. 2126 c.c., secondo cui la nullità o l’annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall’illiceità dell’oggetto o della causa.
Nella fattispecie, infatti, è stata raggiunta la prova che la percezione dei compensi è avvenuta in forza di atti illeciti di rilevanza penale ed è, quindi, esclusa la possibilità di riconoscere la spettanza di tali somme in favore della percipiente, a tutela di una ragionevole convinzione che le somme pagate le fossero realmente dovute.
La giurisprudenza costituzionale, peraltro, ha elaborato il principio per cui l'illiceità che priva il lavoro prestato della tutela collegata al relativo rapporto in seguito a nullità o annullamento del rapporto di lavoro, va ravvisata nel contrasto con norme fondamentali e generali o con i principi basilari dell'ordinamento; la stessa giurisprudenza è categorica nell'affermare che l'art. 36 Cost., presuppone un rapporto di lavoro lecitamente instaurato (Corte cost., sent. 14-19 giugno 1990, n. 296).
Orbene, nella fattispecie in giudizio ricorre sicuramente la violazione delle norme fondamentali del settore, cosicchè deve ritenersi radicalmente illecito, per illiceità della causa, il rapporto di lavoro costituito in violazione delle disposizioni in materia che costituiscono norme di ordine pubblico sociale.
Anna Nardone
Pubblicato su “Il Sole 24 Ore Scuola” n. 12 del 3 - 16 giugno 2010
PART TIME, ALMENO DUE ANNI
Le amministrazione scolastiche possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale sia all’atto dell’assunzione sia mediante trasformazione di rapporti da tempo pieno a tempo parziale, su richiesta dei docenti interessati, nei limiti del 25% della dotazione organica complessiva. Per il reclutamento del personale a tempo parziale è previsto il ricorso alle medesime procedure concorsuali richieste ex lege per il personale a tempo pieno.
In particolare, non è consentito l'impiego di personale a tempo parziale nelle classi delle scuole elementari o nelle sezioni di scuola materna ove l'insegnamento debba essere interamente svolto da un unico docente. Per quanto concerne i docenti dell'istruzione secondaria di primo e secondo grado, al fine di consentire, comunque, la maggiore estensione dei rapporti di lavoro a tempo parziale, i capi di istituto provvedono ad individuare le modalità più opportune di assegnazione su cattedre e posti compatibili con la riduzione di orario. Gli insegnanti di scuola materna con rapporto di lavoro a tempo parziale non possono essere assegnati alle sezioni funzionanti con il solo turno antimeridiano, in quanto occorre assicurare l'unicità di insegnante per sezione; per quanto attiene alle sezioni funzionanti dalle otto alle dieci ore giornaliere è possibile prevedere l'applicazione della disciplina del tempo parziale limitatamente ad una delle due insegnanti assegnate alle sezioni per garantire la stabilità di una figura di riferimento. Per la scuola elementare i direttori didattici, nella procedura di assegnazione degli insegnanti alle classi e di ripartizione tra i medesimi, degli ambiti disciplinari, provvederanno a collocare il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale in posizione compatibile con la necessità di garantire l'unicità dell'insegnante, ove prevista, nonché l'unitarietà degli ambiti nell'intervento formativo. I docenti di scuola secondaria di I grado con rapporto di lavoro a tempo parziale, possono essere assegnati alle cattedre a tempo prolungato, con esclusione di quelle di materie letterarie, attesa la preponderanza di tale insegnamento rispetto all'orario complessivo, nonché al ruolo di riferimento didattico ascrivibile al relativo docente. La realizzazione del part-time nella scuola secondaria deve essere compatibile con l'articolazione oraria delle cattedre nell'ambito dell'organizzazione didattica delle scuole garantendo l'unicità del docente in ciascuna classe e in uno o più degli insegnamenti di cui è composta ciascuna cattedra, in base agli ordinamenti didattici vigenti. Le ore relative alle attività funzionali all'insegnamento sono determinate, di norma, in misura proporzionale all'orario di insegnamento stabilito per il rapporto a tempo parziale. L'insegnamento di sostegno, in ragione delle sue specifiche finalità, viene caratterizzato da attività mirate e ripetute in giorni e fasi successive che non consentono di per se stesse una frammentazione della prestazione dell'insegnante. Pertanto, i docenti di sostegno con rapporto di lavoro a tempo parziale non possono essere utilizzati su posti che comportino interventi di sostegno su singoli alunni di durata superiore alla metà dell'orario settimanale obbligatorio d'insegnamento stabilito per ciascun grado di scuola.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultare da un contratto scritto e deve contenere l’indicazione della durata della prestazione lavorativa e decorre dal primo settembre di ciascun anno successivo all’accoglimento della domanda. La durata del rapporto è di due anni, trascorsi i quali il docente può chiedere il ritorno al tempo normale, presentando la domanda di revoca del part time, di norma entro il 15 del mese di marzo di ciascun anno. I docenti che hanno chiesto e ottenuto la costituzione di rapporti part time per l’anno scolastico precedente non devono ripresentare istanza di conferma per l’anno scolastico successivo. Né è necessaria alcuna richiesta di proroga se al termine dei due anni il personale interessato decida di proseguire. Il rientro a tempo pieno, dopo il prescritto periodo minimo, scatta solo se esplicitamente richiesto. Prima della scadenza del biennio, possono essere accolte domande di ritorno al tempo pieno sulla base però di motivate esigenze e in relazione alla specifica situazione organica.
Al personale insegnante in regime di part time è riconosciuta la facoltà di svolgere altra attività lavorativa, anche subordinata, ma non presso altra amministrazione pubblica, quando l’orario part-time non superi la metà dell’orario pieno. L’attività aggiuntiva non deve costituire un pregiudizio per l'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente, deve essere compatibile con l'orario di insegnamento e di servizio, anche a tempo parziale, e non deve porsi in conflitto di interessi con le funzioni istituzionali svolte nell'ambito dell’amministrazione di appartenenza. Il dipendente è poi tenuto a comunicare, entro quindici giorni, all'Amministrazione nella quale presta servizio, il prossimo inizio o la variazione dell’attività lavorativa svolta in aggiunta al part-time.
Domenico Barboni
Pubblicato su “ Il Sole 24 Ore Scuola” n. 20 del 20 nov. - 3 dic. 2009
CHI ASSISTE UN DISABILE NON PUO’ ESSERE TRASFERITO
L’insegnante che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede per ragioni connesse alle esigenze della pubblica amministrazione, a meno che non sia accertata l’incompatibilità della sua permanenza nella sede di lavoro. Così decidono le sezioni unite della Cassazione con sentenza 9.7.2009 n. 16102, scegliendo di bilanciare i principi avallati dalla legge 104/1992 con i principi costituzionali relativi al buon andamento e imparzialità dei pubblici uffici, finalizzati all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e al raggiungimento dei livelli di efficienza predeterminati per ciascuna struttura della pubblica amministrazione.
La vicenda
Un’insegnante veniva trasferita per incompatibilità ambientale, a causa di comportamenti che avevano generato una situazione di acuta conflittualità con i colleghi, nonché con gli alunni e le loro famiglie. La medesima impugnava il trasferimento sulla base dell’argomento che, assistendo un familiare handicappato con lei convivente, ai sensi della legge n. 104 del 1992 non poteva essere trasferita senza il proprio consenso. La Corte di Cassazione – cui la questione giungeva dopo che i giudici di primo e secondo grado avevano accolto le ragioni dell’insegnante – decide invece per la legittimità del trasferimento per incompatibilità ambientale.
Motivi della decisione
La Cassazione osserva che la legge 104 del 1992 (legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) prevede agevolazioni per i lavoratori che assistono soggetti portatori di handicap. In particolare, dispone che il genitore o il familiare lavoratore che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito, senza il suo consenso, ad altra sede. La tutela è riconosciuta al lavoratore che provveda all'assistenza della persona handicappata pur non essendo con essa convivente, sì che l'agevolazione è diretta non tanto a garantire la presenza del lavoratore nel proprio nucleo familiare, quanto ad evitare che la persona handicappata resti priva di assistenza in relazione alla sede lavorativa del familiare che la assiste; e, d'altra parte, un'uguale agevolazione, quanto alla scelta della sede di lavoro e alla inamovibilità, è prevista in favore della persona handicappata in situazione di gravità, così confermandosi che, in generale, il destinatario della tutela realizzata mediante le agevolazioni previste dalla legge non è il nucleo familiare in sé, bensì la persona portatrice dì handicap. Una configurazione siffatta, d'altronde, è in linea con la definizione contenuta nella Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, approvata il 13.12.2006, là dove la finalità comune dei diversi ordinamenti viene identificata nella piena ed effettiva partecipazione nella società su una base di eguaglianza con gli altri. L'efficacia di questa tutela si realizza, per quanto qui interessa, anche mediante una regolamentazione del contratto di lavoro in cui è parte il familiare della persona tutelata, là dove il riconoscimento di diritti in capo al lavoratore è in funzione del diritto del portatore dì handicap a ricevere assistenza.
In considerazione anche degli orientamenti della Corte costituzionale, le Sezioni unite, occupandosi del diritto dì scelta della sede di lavoro a conclusione di una procedura concorsuale pubblica, hanno già avuto modo di rilevare che la legge 104 del 1992 non configura in generale, in capo ai soggetti ivi individuati, un diritto assoluto e illimitato, poiché esso può essere fatto valere allorquando, alla stregua di un equo bilanciamento fra tutti gli implicati interessi costituzionalmente rilevanti, il suo esercizio non finisca per ledere in maniera consistente le esigenze economiche, produttive ed organizzative del datore di lavoro e per tradursi - soprattutto nei casi relativi a rapporti di lavoro pubblico - in un danno per l’interesse della collettività (cfr. Cass., sez. un., n. 7945 del 2008). La limitazione del diritto, in ragione della concomitanza di valori di rilievo costituzionale, si esplicita nella norma, con riguardo alla scelta della sede di lavoro all'atto dell'assunzione con l'inciso "ove possibile", che vale a configurare una subordinazione del diritto alla condizione che il suo esercizio non determini – in ipotesi di lavoro pubblico - un danno per la collettività compromettendo il buon andamento e l'efficienza della pubblica amministrazione. La mancanza di tale esplicitazione per l'ipotesi del trasferimento è collegata alla diversità delle due situazioni, e specificamente ai riflessi negativi per il portatore di handicap di un trasferimento di sede del congiunto a fronte di una situazione assistenziale già consolidata. Tuttavia, la scelta operata dal Legislatore significa soltanto che in questa ipotesi l'interesse della persona handicappata, ponendosi come limite esterno del potere datoriale di trasferimento, prevale sulle ordinarie esigenze produttive e organizzative del datore dì lavoro; ma non esclude che il medesimo interesse debba conciliarsi con altri rilevanti interessi che possono entrare in gioco nello svolgimento del rapporto di lavoro, pubblico o privato, la cui considerazione può determinare, concretamente, un limite alla prescrizione di inamovibilità. A tale proposito, la giurisprudenza ha individuato situazioni di incompatibilità ambientale che si distinguono dalle ordinarie esigenze di assetto organizzativo realizzando, di per sé, un'obiettiva esigenza di modifica del luogo di lavoro (cfr. Cass. n. 4265 del 2007; Cass. n. 10252 del 1995). La particolarità delle esigenze sottese a tali situazioni riconducibili a valori di rilievo costituzionale determina la inapplicabilità, in caso di incompatibilità ambientale, della citata tutela di cui alla legge 104 del 1992, che riguarda invece le ipotesi di mobilità dei lavoratori per ordinarie ragioni tecnico-produttive.
Anna Nardone
Pubblicato su “ Il Sole 24 Ore Scuola” n. 15 del 11-24 sett. 2009
Maternità
SE IL PARTO E’ GEMELLARE NON E’ DOPPIO CONGEDO
In caso di parto plurimo, alla docente non spetta la moltiplicazione del periodo di congedo parentale (già astensione facoltativa dal lavoro per maternità) con retribuzione intera in conformità alle previsioni della contrattazione collettiva di comparto. Così decide il Tribunale del Lavoro di Modena, con sentenza 584/2008.
La vicenda
Una docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato era divenuta madre di due gemelle. Terminato il periodo di congedo di maternità obbligatoria, la ricorrente aveva chiesto all'amministrazione scolastica di poter usufruire di un periodo di congedo parentale (già astensione facoltativa) di un mese per un prima figlia; di un altro mese per l’altra figlia, entrambi con una retribuzione al 100%, come previsto dalla contrattazione collettiva di settore. Tale beneficio veniva inizialmente accordato dalla scuola di servizio, tuttavia, a seguito di rilievo della Ragioneria Provinciale dello Stato, l'amministrazione scolastica provvedeva a recuperare il 70% della retribuzione. Non condividendo tale posizione, la ricorrente si rivolgeva al giudice del lavoro. Deduceva quest'ultima che l'articolo 32 del testo unico 151/2001 disponeva il diritto ai congedi parentali per ogni figlio, nei suoi primi otto anni di vita, sicché il lavoratore dipendente aveva diritto alla moltiplicazione dei periodi di astensione facoltativa in relazione al numero dei figli, anche se gemelli, e l'articolo 12 del contratto collettivo per la scuola sanciva l'applicabilità al personale della scuola delle vigenti disposizioni in materia di congedi parentali, di più stabilendo che i primi 30 giorni di congedo parentale siano retribuiti nella misura del 100% della retribuzione. Ritenendo che a fronte della duplicazione dei congedi parentali l'articolo 12 del CCNL della scuola potesse consentire la duplicazione anche dei benefici retributivi, la ricorrente chiedeva due mesi di astensione facoltativa al 100% dello stipendio, uno per ciascuna figlia. Il Tribunale di Modena ritiene di rigettare l'istanza della ricorrente.
Motivi della decisione
Osserva il giudice adito che l'articolo 32 del d.lgs. 151 / 2001 stabilisce che "per ogni bambino, nei primi suoi otto anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo […] il diritto di astenersi dal lavoro compete: a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al capo III, per un periodo continuativo frazionato non superiore a sei mesi”. L'articolo 34 prevede poi che "per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta sino al terzo anno di vita del bambino, un'indennità pari al 30% della retribuzione". Le norme di cui sopra disciplinano sia il periodo di congedo parentale che compete dopo la nascita dei figli, sia il relativo trattamento economico che compete durante il periodo di congedo parentale. Tali norme prendono anche in considerazione l'ipotesi di parto plurimo (l’articolo 32: "per ogni bambino..."; l’articolo 34: "per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32..." ). A sua volta, il contratto collettivo del comparto scuola prevede una disciplina più favorevole, per il trattamento economico, rispetto alla disciplina valida per tutti i lavoratori pubblici e privati prevista dal d.lgs. 151/2001. In particolare, l'articolo 12 CCNL dispone che "nell'ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall'articolo 32, comma uno, lettera a) del D.lgs n. 151/2001, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi 30 giorni […] non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio e sono retribuiti per intero". Tale norma, facendo riferimento all'articolo 32 del d.lgs n. 151/2001 già ricomprende l'ipotesi (prevista e disciplinata da detto articolo) di parto plurimo, stabilendo che nel periodo di fruizione del congedo facoltativo i primi 30 giorni sono retribuiti per intero. Ove la norma contrattuale avesse voluto disporre una moltiplicazione o comunque un aumento della parte del periodo di congedo retribuito per intero in relazione al numero dei figli non avrebbe mancato di specificare tale diritto del lavoratore. Ciò è del resto avvenuto per i periodi di riposo: infatti una apposita norma prevede espressamente che in caso di parto plurimo i periodi di riposo sono raddoppiati: ciò significa che in caso di nascita di due o più figli le ore di riposo spettanti sono il doppio rispetto all'ipotesi di parto singolo. A contrario – conclude il Tribunale di Modena – alla docente ricorrente compete il pagamento dell'intera retribuzione per i primi 30 giorni del fruito periodo di congedo parentale e, in forza del richiamo operato dal comma 1 dell'articolo 12 del menzionato CCNL, per il periodo successivo compete il pagamento del 30% della retribuzione. Si da atto che lo stesso organo giudicante, infine, ammette l’opinabilità della materia di cui è causa. A tale proposito, giova ricordare che la giurisprudenza è unanime nel giudicare che i periodi di congedo parentale – già astensione facoltativa dal lavoro per maternità – al pari di quelli di astensione obbligatoria, devono essere computati a tutti gli effetti nell'anzianità di servizio del dipendente pubblico. Infatti, la circostanza che l'astensione facoltativa si ponga per definizione come frutto di libera scelta dell'interessata non toglie, infatti, che la medesima sia rivolta alla tutela della prole, ossia al soddisfacimento di esigenze intimamente compenetrate con la tutela della maternità naturale posta a fondamento dell'astensione obbligatoria - in un'ottica di naturale continuazione. Così si conferma l’equiparazione del congedo parentale- astensione facoltativa all'effettiva prestazione di servizio, salvo che ai fini delle ferie, della tredicesima mensilità e della gratifica natalizia (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 13.11.2007 n. 5797; Cons. Stato, sez. VI, 26.4.2002, n. 2254; Cons. Stato, sez. VI, 9.4.2000, n. 2038; Cons. Stato, sez. II, parere 17.10.1990; Cons. Stato, sez. VI, 16.5.2001, n. 2760).
Anna Nardone
Pubblicato su “ Il Sole 24 Ore Scuola” n. 11 del 29 mag. – 11 giu. 2009
STRAORDINARIO RETRIBUITO ANCHE SE OLTRE IL LIMITE
Sono retribuibili le ore straordinarie prestate dal dipendente su incarico dell’amministrazione, anche in eccedenza al limite massimo annuo previsto dagli accordi nazionali e dalle circolari applicative. Così si pronuncia il TAR Puglia – Sezione di Lecce, con sentenza n. 3227 del 15 ottobre 2008. /2008 confermando la prevalenza del principio costituzionale che sancisce l’imprescindibile diritto al compenso per le prestazioni svolte.
La vicenda
Un dipendente pubblico, dopo aver svolto numerosissime ore di straordinario su preciso ordine dell’amministrazione di appartenenza, al momento del pagamento si vedeva opporre dalla stessa pubblica amministrazione un rifiuto motivato sull’argomentazione che il numero di ore di cui si domandava la retribuzione eccedevano il limite massimo previsto da norme concordate e disposizioni ministeriali attuative. Il dipendente chiedeva allora al tribunale amministrativo pugliese che l’amministrazione di appartenenza venisse condannata al pagamento in suo favore della somma richiesta a titolo di compenso per il lavoro straordinario effettuato. Il Tribunale accoglieva le istanze del dipendente. Degna di nota la circostanza che la sentenza definitiva era preceduta dal’emissione di un decreto ingiuntivo in favore del ricorrente.
Motivi della decisione
Il giudice amministrativo muove dalla premessa che, nella vicenda di cui è causa, non sussiste contrasto fra le parti circa l’effettivo svolgimento da parte del dipendente delle ore di lavoro straordinario per cui è chiesto il compenso, né sul fatto che tali prestazioni sono state effettuate in esecuzione di un ordine di servizio adottato dal dirigente competente. Com’è noto, secondo la costante giurisprudenza la retribuibilità del lavoro straordinario prestato dal pubblico dipendente è condizionata dall’autorizzazione preventiva e formale dell’amministrazione di appartenenza. Infatti, solo un atto preventivo e in forma scritta dell’amministrazione può consentire di verificare in concreto la sussistenza delle ragioni di pubblico interesse che rendono necessario il ricorso a prestazioni lavorative eccedenti l’orario normale di lavoro, in linea con i principi costituzionali di legalità, buon andamento e imparzialità, secondo i quali devono essere organizzati i pubblici uffici. Addirittura, l’autorizzazione deve contenere l’indicazione nominativa dei dipendenti autorizzati alle prestazioni straordinarie. Solo se il lavoro straordinario è stato svolto per inderogabili esigenze di servizio, è ipotizzabile un successivo atto di ratifica, in forma scritta, nel quale l’amministrazione deve indicare specificamente le ineluttabili necessità di servizio. In mancanza di un riconoscimento formale da parte della pubblica amministrazione dell’utilità del lavoro svolto d’iniziativa, al dipendente nulla spetta, neppure a titolo di indennizzo per arricchimento senza causa. Per l’effetto, è consigliabile pretendere dal diretto superiore una attestazione chiara sulla necessità dello svolgimento del lavoro straordinario nonché sulla quantità di tale lavoro, rendendo così doverosa la prestazione lavorativa, con tutte le conseguenze sul piano retributivo e previdenziale.
Chiarito ciò, il TAR Puglia evidenzia come le ragioni di carattere giuridico che l’amministrazione frappone all’accoglimento della domanda del dipendente sono del tutto inconferenti. Il Ministero infatti deduceva che l’accordo nazionale quadro di amministrazione e i successivi atti applicativi adottati pongono un limite alle prestazioni di lavoro straordinario del personale retribuibili annualmente; con provvedimento motivato del dirigente competente tale limite può essere derogato, ma le ore di straordinario retribuibili mensilmente non possono essere superiori al limite, di tal chè le ore eccedenti tale limite debbono essere trasformate in recupero compensativo.
Il Tribunale ritiene invece che la pretesa del ricorrente non può essere limitata dalla norma che fissa un monte-ore annuo di straordinario che il personale ha diritto a vedersi retribuito in denaro. Senza con questo sostenere che una siffatta disposizione non abbia alcun valore, ma solo che essa non può essere opposta al dipendente che, regolarmente comandato a svolgere servizi per un tempo eccedente il normale orario di lavoro (e anche il predetto monte-ore), pretenda il pagamento del compenso per lavoro straordinario. Incombe invece sul dirigente verificare che non venga superato il monte-ore annuo, disponendo, ad esempio, il recupero compensativo per le ore di straordinario eccedenti il budget finanziario disponibile (il quale costituisce per il dirigente il parametro di riferimento per la corretta gestione del personale). Tale onere non può certo essere addossato al dipendente, il quale, fra l’altro, ha l’obbligo di eseguire gli ordini di servizio, salvo che il loro adempimento con configuri un reato. A voler opinare diversamente, il dipendente sarebbe gravemente pregiudicato, non potendo rifiutarsi di svolgere il lavoro straordinario e non potendo però pretendere il relativo compenso. Per quanto riguarda, poi, il recupero compensativo, la giurisprudenza è concorde nell’affermare che tale forma alternativa di ristoro del dipendente chiamato a svolgere lavoro straordinario deve di norma essere attivata dall’amministrazione datrice di lavoro entro un breve termine dal momento in cui la prestazione lavorativa è stata svolta, pena la sostanziale frustrazione della ratio del recupero compensativo (in terminis, TAR Lecce, II, nn. 8430/2004, 8431/2004 e 8432/2004). Nel caso di specie, invece, sono trascorsi quasi due anni da quando il ricorrente veniva regolarmente comandato a prestare il servizio straordinario ed è quindi impossibile ricorrere all’istituto del recupero compensativo che – come ricordato - per assolvere alla sua funzione tipica, deve essere fruito dal dipendente a ridosso dello svolgimento del lavoro straordinario.
Per effetto di tali argomenti, il giudice accerta il diritto del dipendente al pagamento delle somme richieste a titolo di retribuzione per le ore di straordinario regolarmente svolte.
Anna Nardone
Pubblicato su “ Il Sole 24 Ore Scuola” n. 1 del 9-22 gennaio 2009
COLLABORAZIONI DISCIPLINATE
Le scuole private non sono tenute al rispetto della disciplina dei rapporti individuali di lavoro contenute nella contrattazione collettiva nazionale, che al contrario vincola le scuole pubbliche – statali e paritarie. In particolare, le istituzioni private possono attivare contratti di collaborazione con i docenti, mentre nelle scuole pubbliche il massimo della flessibilità per il personale insegnante è dato dal contratto a tempo determinato. Ciò dava vita, nel recente passato, ad un intrico di rapporti di lavoro subordinato e collaborazioni nel settore dell’istruzione privata, che da tempo reclamava un intervento chiarificatore dello Stato. Con una circolare del ministero del lavoro del 2006 sono stati così fissati alcuni criteri per controllare il corretto ricorso alle collaborazioni nelle aziende, ed anche negli istituti non statali. Tale intervento si era necessario soprattutto dopo che l'entrata in vigore della riforma Biagi del mercato del lavoro aveva definitivamente congedato le co.co.co, sostituite con i contratti a progetto, una forma di lavoro flessibile a cui le imprese possono ricorrere solo per attività non ripetitive e non predeterminate, e che, soprattutto, non coincidono con l'oggetto principale dell'attività d'impresa; che necessitano di un contratto in forma scritta, che definisca le prestazioni e il compenso. Tali paletti, desunti e desumibili dalla riforma Biagi, non erano però bastati, secondo le denunce sindacali, a evitare abusi; e tra i settori sotto accusa c’erano in particolare le scuole private. Secondo le norme ministeriali richiamate, e in ottemperanza alle disposizioni della legge di riforma, presso le scuole non statali i rapporti di collaborazione – nella nuova forma di contratto a progetto – possono essere istaurati solo per discipline non curriculari: al contrario, per le materie del curriculum obbligatorio devono essere creati rapporti di lavoro subordinato, anche per i contratti a tempo determinato. Con la conseguenza che due docenti precari di un istituto privato possono avere una collaborazione o un rapporto subordinato, con differenti regimi retributivi e contributivi, a seconda della materia che insegnano. Le norme citate prevedono anche ispettori che controllino il rispetto dei principi affermati, attraverso attente verifiche sulle tipologie di contratto utilizzate nei confronti degli insegnanti, soprattutto di quelli assunti a tempo determinato.
Diverso è il discorso valido per le scuole paritarie, le quali, unitamente alle scuole statali e a quelle degli enti locali, costituiscono per legge il sistema nazionale di istruzione, e sono perciò sottoposte alla stessa disciplina contrattuale nazionale. Il legislatore, tra i requisiti fondamentali per l’accesso allo status di scuola paritaria, ha infatti inserito il vincolo dell’applicazione dei contratti collettivi, ammettendo che si possa ricorrere a prestazione autonome e volontarie al massimo per il 25% dell’attività di docenza complessiva. E così, anche il contratto a progetto - introdotto nell’ordinamento con la riforma Biagi - sembra trovare una limitata applicazione nelle scuole paritarie: esclusa la sua riconducibilità all’area del lavoro subordinato, la sua utilizzazione potrebbe rimanere circoscritta a quel 25% di attività di insegnamento per la quale si può ricorrere a forme di lavoro autonomo. S’aggiunga che lo stesso Ministero dell’Istruzione, già con circolare del 2003, aveva definito come subordinata la prestazione lavorativa del docente di scuola paritaria, come tale soggetta alla disciplina contrattuale di riferimento, ed alle condizioni economiche e normative dalla stessa previste. A tale ultimo proposito, con riferimento alle scuole private non statali, non è raro che queste ultime identifichino come autonomo o parasubordinato il rapporto con i propri docenti per sottrarsi agli obblighi di legge, quali la retribuzione dei mesi estivi, le mensilità aggiuntive, il trattamento di fine rapporto. La Corte di Cassazione si è più volte occupata del problema, risolvendolo a favore del lavoratore. In particolare, ha affermato che sono determinanti ai fini della qualificazione del rapporto come subordinato – e quindi del riconoscimento dei conseguenti benefici di legge -, non tanto il nome giuridico fornito dalle parti, quanto il concreto assoggettamento del docente al potere di coordinamento, di controllo e disciplinare del datore di lavoro; il suo inserimento nell’organizzazione aziendale; il sistema retributivo, commisurato alle ore di insegnamento; l’orario di lavoro fissato con disposizione cogente; attività ausiliarie - colloqui con le famiglie, partecipazioni alle riunioni con gli altri docenti e agli scrutini – ugualmente imposte da superiori istanze; l’inserimento funzionale dell’insegnante nell’impresa scolastica, dove il rischio di gestione grava esclusivamente sul titolare, che mette a disposizione i mezzi strumentali necessari per l’espletamento dell’attività didattica, senza alcuna conseguente assunzione di rischio da parte del docente e senza la benché minima partecipazione del lavoratore all’acquisto degli strumenti predetti.
Domenico Barboni
Pubblicato su “ Il Sole 24 Ore Scuola” n. 10 del 16-29 mag. 2008
QUANDO I PROF. ENTRANO IN CAUSA.
In tema di responsabilità degli insegnanti di scuole statali, l'art. 61, c. 2, della legge 11 luglio 1980 n. 312 prevede la sostituzione dell'Amministrazione scolastica, salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, nella responsabilità civile derivante da azioni giudiziarie promosse da terzi. La norma esclude cioè la possibilità che gli insegnanti statali siano direttamente chiamati in giudizio da terzi nelle azioni di risarcimento del danno da culpa in vigilando, quale che sia il titolo - contrattuale o extracontrattuale - dell'azione. Ne deriva, pertanto, che l'insegnante non può essere chiamato in causa in ipotesi di azione per danni arrecati da un alunno ad altro alunno, nella quale sia invocata, nell'ambito di un'azione di responsabilità extracontrattuale, la presunzione di cui all’art. 2048, c. 2, c.c. Ma neppure nell'ipotesi di azione per danni arrecati dall'allievo a se stesso, da far valere secondo i principi della responsabilità contrattuale ex art. 1218, c.c.. In entrambi i casi, qualora l'Amministrazione sia condannata a risarcire il danno al terzo - ed è tale, rispetto al successivo rapporto di rivalsa tra Amministrazione ed insegnante, anche l'alunno che sì sia autodanneggiato - l'insegnante sarà successivamente obbligato in via di rivalsa soltanto nel caso in cui sia dimostrata la sussistenza del dolo o della colpa grave. La stessa Corte costituzionale, ha escluso che tale privilegio processuale sia in contrasto con l'art. 28 della Costituzione, secondo il quale i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti e in tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici (Sentenza n. 64/1992). La limitazione ai soli casi di dolo o colpa grave della responsabilità del personale insegnante verso l'Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamento degli alunni sottoposti alla vigilanza, va intesa - con stretta aderenza alla lettera della norma - nel senso che il limite è fissato verso l'Amministrazione e non verso i terzi. Si tratta, quindi, di un limite destinato ad operare soltanto nell'ambito dell'eventuale giudizio dì rivalsa che l'Amministrazione intraprenda contro l'insegnante davanti alla Corte dei conti, dopo aver subito una condanna a favore del terzo danneggiato. Non pare infatti condivisibile la tesi secondo cui la norma richiamata, ponendo la menzionata limitazione, escluderebbe l'applicabilità della presunzione di responsabilità prevista dall’art. 2048, c. 2, c.c., anche nelle controversie di risarcimento danni per culpa in vigilando promosse da terzi nei confronti degli insegnanti statali, ed addirittura anche nei confronti dell'Amministrazione. Per quanto concerne l'Amministrazione, è infatti sufficiente notare che il citato art. 61 è ispirato da esigenze di tutela verso il personale scolastico, e non già verso l'Amministrazione, per cui eccede manifestamente le finalità della norma volgerla a tutela di quest'ultima, esentandola, senza plausibile ragione, dalla presunzione di cui all'art. 2048, c. 2, c.c., nei giudizi di responsabilità connessa all'attività di vigilanza sugli alunni promossi da terzi danneggiati, così determinando un ingiustificato aggravio, sul piano probatorio, della posizione processuale del danneggiato. Quanto agli insegnanti, la sottrazione degli insegnanti statali alle conseguenze, ritenute troppo gravose della affermata applicabilità nei loro confronti della presunzione di cui all'art. 2048, c. 2, c.c., nei giudizi di danno per culpa in vigilando, è realizzata con la citata l. n. 312/1980 non già sul piano sostanziale, bensì esclusivamente sul piano processuale, stabilendo che, salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l'Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi.
Domenico Barboni
Pubblicato su “il sole 24 ore scuola” del 30 aprile 2004.